
Home - Messaggi - Maestri - Autori - Arcana Arcanorum - Corpus Magiae - Biblioteca - Dossier - Napoli - Religioni - Luoghi - Vitriol - Miscellanea - Filmati

ricerche a cura del dott. Luigi Braco
Vita e Opere
Alphonse-Louis Constant (1810-1875), vero nome di Éliphas Lévi, nasce a Parigi nel 1810, da padre calzolaio e madre religiosa ma analfabeta. Compie i primi studi grazie a l’abate Hubault Mailmason che dispensava le prime basi dell’istruzione scolastica ai bambini poveri delle sua parrocchia. Nel 1825 continua gli studi al seminario minore di Saint Nicolas du Chardonnet, diretto dall’abate Colonna, che come riportano alcune fonti, gli avrebbe trasmesso il primo interesse per la magia. Nel 1830, secondo la regola del seminario, passa al seminario d’Issy per continuare il biennio in filosofia. Muore il padre. Constant, proseguendo regolarmente negli studi, arriva al seminario di Saint Sulpice per dedicarsi alla teologia.
Saint Sulpice
Nel 1835, durante il catechismo, la madre di Adèle Allenbach, una sua allieva, lo prega di seguire la figlia, istruendola a parte e proteggendola come se fosse la figlia di un principe. La madre di Adèle era una fervente cattolica sposata ad un’ufficiale svizzero, emigrata in Francia per salvaguardare la religiosità minacciata della figlia; il trasferimento aveva portato le due donne a vivere in uno stato d’indigenza. Constant s’innamora perdutamente dell’allieva, in cui arriva addirittura a credere di vedere l’incarnazione della santa Vergine. Il 19 dicembre 1835 viene ordinato diacono; ma nel giugno del 1836, prima di ricevere il sacramento dell’ordine, abbandona il seminario pur di non rinunciare alla passione per Adèle. La relazione con la ragazza, tuttavia, finisce. La madre di Constant, vecchia e malata, avendo riposto tutte le speranze nella carriera ecclesiastica del figlio, si suicida. Constant medita di ritirarsi in un convento di trappisti, ma gli amici lo dissuadono. Passa un anno in un pensionato di Parigi, dove conosce Bailleul, un commediante ambulante che decide di accompagnare in tournée attraverso la provincia. Nel 1838 conosce la giovane socialista Flora Tristan e collabora con Alphonse Esquiros, incontrato ad uno spettacolo. Conosce anche Honorè de Balzac a casa di Madame de Gerardin. Constant però decide di riprovare con la vita sacerdotale e raggiunge l’abbazia di Solesmes, dove vorrebbe passare il resto dei suoi giorni.

abbazia di Solesmes
L’abbazia possiede un’immensa biblioteca, con circa 20.000 volumi, a cui attinge a piene mani. Constant studia la dottrina degli antichi gnostici, quella dei Padri della Chiesa Primitiva, i libri di Cassiano e degli altri asceti, oltre che trattati di mistica e gli scritti di Guyon. Secondo alcune fonti, in questo periodo, egli scrive la sua prima opera le "Rosier de Mai", 1839.
A causa di dissapori con l’abate di Solesmes, lascia il convento prima della fine dell’anno. Constant si trova ora in gravi difficoltà economiche. Grazie all’intervento dell’arcivescovo di Parigi, Constant ottiene un posto di sorvegliante al collegio di Juilly. Il salario è pessimo ed i superiori lo maltrattano: Constant per reazione scrive la "Bible de la Libertè", 1841.
Le copie furono sequestrate dopo un’ora dalla data di uscita del libro, era il 13 febbraio. Molte copie furono nascoste alla censura, ma Constant fu arrestato il 1 aprile 1841. L’11 maggio si svolse il processo, e Constant viene condannato a 8 mesi di detenzione e ad un’ammenda di 300 franchi. Constant che non possiede i franchi necessari a pagare l’ammenda, deve scontare 11 mesi alla prigione di Sainte Pèlagie, dove ritrova Esquiros e l’abbate di Lammenais. In carcere si cerca con tutti i mezzi di provocare il suicidio di Constant, accusandolo di essere una spia e mettendolo in cattiva luce di fronte agli altri detenuti. Constant, che passa il tempo nella consolazione della lettura, conosce così casualmente l’opera di Swedenborg. Grazie ai favori di una ricca amica, Mme Legrand, riesce a mitigare la durezza della sua detenzione e ad ottenere un’alimentazione più variegata. Grazie al cappellano di Sainte Pèlagie viene incaricato di pitturare i muri della chiesa di Choisy le Roi. Nel 1843 mentre abita nel presbiterio di Choisy, comincia a scrivere "La Mère de Dieu". Grazie alla sua condotta esemplare, il vescovo di Evreux s’interessa del suo caso ed è pronto ad intercedere per lui, a condizione che Constant adotti il cognome materno per non far capire che è l’autore di "Bible de la Libertè". Constant accetta e diventa quindi l’abate Baucourt, parte per Evreux, ed inizia a predicare, riscuotendo un grande successo e scatenando le gelosie degli altri chierici. Ma nel giugno dello stesso anno il sotterfugio viene scoperto. Il giornale L’Universo annuncia la morte dell’abbate Constant, informazione che viene subito smentita da un altro giornale, Il Popolare. L’Eco della Normandia, pubblica un articolo intitolato Il Nuovo Lazzaro, in cui si svela l’identità e la vera storia dell’abate Baucourt. Monta lo scandalo, anche per la contemporanea uscita di "La Mère de Dieu", e Constant è costretto ad abbandonare il suo lavoro ed a ritornare a Parigi.
Nel frattempo rivede Tristan, che morirà un mese dopo, Constant s’interroga sull’opportunità di pubblicare un manoscritto di Tristan, che potrebbe causargli nuovi problemi con le autorità. Decide infine di pubblicare con il titolo "L’emancipation de la Femme ou le Testament de la Paria".
Nel 1844 si reca a Guitrancourt come educatore privato; ritornato a Parigi pubblica un manifesto pacifista ispirato a Silvio Pellico, "La Fête Dieu ou le Triomphe de la Paix Religieuse", 1845. In questo periodo Constant s’interessa attivamente al pensiero utopico di Foriér e Saint-Simon. Nel 1845 scrive "Le Livre des Larmes", dove appaiono le prime nozioni sull’occultismo.
Si rivede con Adèle Allenbach, divenuta nel frattempo attrice. Nel 1845, insieme a Charles Fauvety, fonda la rivista La Vérité sur toutes choses, che uscirà soltanto i primi quattro mesi. Ritorna ad Choisy le Roi dove aveva rincontrato nel 1843 Eugénie Chenevier, maestra all’Istituto Chandeau. All’Istituto soggiorna pensione presso una giovane di nome Marie Noèmi Cadiot, molto amica di Eugénie. La domenica Constant accompagna spesso a passeggio le due giovani. Eugeniè accetta la proposta di matrimonio di Constant: la donna si era già donata a lui, ed era ora in attesa del primogenito Xavier Henri Alphonse Chevenier, 1846-1916.


Eugénie Chenevier Alphonse Chevenier
Ma anche Marie Noèmi s’innamora di Constant, e dopo un lungo carteggio appassionato, scappa di casa e si rifugia nella mansarda di lui. Constant per evitare la denuncia di sottrazione di minore, la fanciulla aveva allora appena 18 anni, è costretto alle nozze riparatrici. La famiglia di Marie Noèmi non aveva lasciato la dote alla figlia; i giovani sposi vivono quindi in una grave indigenza, che li costringe sovente a saltare i pasti e a nutrirsi soltanto di patate fritte

Dopo la pubblicazione di "Bible de la Libertè", viene impedito a Constant di esprimere il suo pensiero. Egli si rimette tuttavia a fare politica, su suggerimento di Noèmi. Decide di pubblicare su di un giornale il pamphlet "La Voix de la famine". Il 3 febbraio del 1847 è ancora condannato ad un anno di detenzione e al pagamento di un’ammenda di 1000 franchi. Noèmi, che nel frattempo è in stato interessante, chiede la grazia per il marito, e riesce a fargli avere una riduzione di sei mesi. Nel settembre del 1847 nasce Marie, che tuttavia morirà sette anni dopo, provocando un grande dolore a Constant e Noèmi. Durante la rivoluzione del 1848 Constant dirige una rivista gauchista, "Le Tribun du Peuple", che non supererà i primi quattro numeri. Fonda un club politico, il Club de la Montagne. A giugno scoppiano le insurrezioni delle classi lavoratrici. Il 23 giugno del 1848, Constant rischia grosso: un mercante di vino, viene scambiato con lui, e fucilato in piazza. Constant prova a candidarsi senza successo come rappresentante del popolo all’Assemblea Nazionale: la spunta al suo posto Esquiros, e i due ex amici non s’incontreranno più. Constant scrive l’ultimo libro sulla politica, "Le Testament de la Libérte".
Intanto Noèmi scrive dei feuilletons letterari usando uno pseudonimo, ed incontra un discreto successo. Frequenta anche le lezioni di scultura di Pradier, un’artista dell’epoca molto famoso. Constant ottiene delle commissioni dal Ministero dell’Interno. Constant legge la "Cabbala Denudata" di Knorr de Rosenroth, studia gli scritti di Boehme, Saint-Martin, Sweedenborg, Fabre d’Olivet. Nel 1850, l’abbate Migne, chiede a Constant di scrivere un dizionario della letteratura cristiana. L’opera esce nel 1851, suscitando un grande stupore per le profonde conoscenze dell’autore. Alla fine del 1850, Constant conosce Hoenè Wronski, che era rimasto favorevolmente impressionato dal "Dictionnaire" e che lo indirizza alla matematica e al pensiero messianico. Comincia allora a lavorare al prossimo libro, "Dogme et Rituel de la Haute Magie", ed assume lo pseudonimo di Éliphas Lévi Zahed, traduzione ebraica di Alphonse Louis Constant. Intanto Noèmi, che aveva iniziato una relazione clandestina con il cognato di Wronski, il marchese di Montfernier, lascia il marito. Constant accusa il colpo e cerca di dimenticare gettandosi a capofitto nei suoi progetti. Nella primavera del 1854 entra a far parte di una società rosacruciana, introdottovi dallo scrittore di romanzi fantastici sir Edward Bulwer Lytton. Su richiesta di un iniziato agli alti gradi, Éliphas si cimenta in una serie di evocazioni. Durante una di queste, gli appare lo spirito di Apollonio di Tirana, che gli indica Lourdes, come il luogo dove potrà trovare Nyctemeron, di cui aveva parlato in Dogme et Rituel de la Haute Magie. Éliphas Lévi si ripromette allora di non cimentarsi più nella magia operativa; quando in seguito avrà degli allievi, farà loro prestare dei giuramento di rinuncia agli esperimenti e di impegno esclusivo nella parte speculativa della filosofia occulta. Nel frattempo Éliphas Lévi scrive a Eugénie Chenevier, che viveva a Londra, per chiedere notizie sul figlio che non aveva riconosciuto, ed anche per chiedere il perdono. Nell’agosto del 1854 Éliphas alloggia nell’atelier di un suo amico pittore, e finisce Dogme et Rituel de la Haute Magie, che esce alla fine dell’anno.
Nel 1855, fonda con Fauvety e Lemmonier la "Revue Philosophique et Religieuse", che cesserà le pubblicazioni dopo tre anni, su cui pubblica degli articoli sulla Cabbala. Éliphas però si mette di nuovo nei guai. Trascurando gli studi, scrive delle canzoni in cui paragona Napoleone III a Caligola. Éliphas finisce di nuovo in prigione. Riesce subito ad uscire, perché scrive un’altra canzone in cui dichiara di non aver mai paragonato nessuno a Caligola; la fa leggere all’imperatore, che lo scagiona. Una volta uscito, continua a scrivere canzoni. Il 1 gennaio del 1857, Éliphas ha un sogno premonitore, che finisce con una strana frase: “vieni a vedere tuo padre che sta per morire”. Éliphas non riesce a comprendere il senso di questo sogno, perché suo padre era ormai morto da molti anni. Due giorni, dopo assiste tra la folla alla cerimonia d’inaugurazione della basilica di Sainte Geneviève a Sainte Etienne du Mont. Durante la cerimonia l’arcivescovo di Parigi viene assassinato da un prete interdetto. Éliphas leggendo sui giornali la descrizione dell’assassino, si ricorda di averlo incontrato una sera a casa di un’amica, e che il prete omicida, gli aveva confidato che stava ricercando il grimoire di Honorius. Nel 1859 pubblica l’Histoire de la Magie, che riscuote un notevole successo e gli fa conoscere molti esponenti dell’esoterismo dell’epoca come Henri Delaage, Luc Desages, Paul Augez, Jean-Marie Ragon, Henri Favre, Fernand Rozier, il cartomante Edmond e l’ipnotizzatore Cahagnet.
Il 14 maggio 1861 riceve l’iniziazione massonica. Dopo il rito, alla presenza di un grande numero di Fratelli, gli viene concessa subito la parola per spiegare l’origine cabbalistica del simbolismo massonico: tuttavia il tentativo non riscuote un grande successo. Nello stesso anno, Eugeniè e suo figlio ritornano a Parigi; Éliphas fa sapere alla madre che desidera occuparsi di suo figlio, ma finiscono per litigare per questioni economiche. Éliphas non rivedrà più Eugeniè, né suo figlio fino al momento della sua morte. Nello stesso anno pubblica "La Clef des Grands Mysteres".
Nel frattempo Éliphas continua le sue lezioni sulle scienze occulte, di fronte ad un grande numero di eruditi, appartenenti all’aristocrazia parigina; uno di questi è addirittura il vescovo di Evreux, Mgr. Devoucoux, a cui impartisce lezioni di Cabbala. Éliphas, grazie ai proventi della vendita del libro e delle lezioni, vive ora in una discreta condizione economica, che gli permette di acquistare numerosi libri. Insieme al conte Alexandre Branicki, si cimenta in qualche esperimento alchemico nel laboratorio del castello di Beauregard, a Villeneuve Saint Georges. Il castello era di proprietà di Balzac, ed Éliphas diventa così amico del genero della vedova. Il castello, dopo il saccheggio dei prussiani nel 1870, è stato adibito a municipio della città. Nel maggio del 1861, ritorna a Londra accompagnato dal conte, soggiorna da Bulwer Lytton, che era arrivato ad essere a capo della Rosicrucian Society of England. Nel luglio del 1861, Éliphas conosce un suo importante estimatore, che diventerà anche il suo mecenate: il barone Spedalieri. Tra i due incomincia una fitta carteggio, più di mille lettere, che durerà fino al 14 febbraio 1874. Praticamente, si tratta di un corso sulla Cabbala per corrispondenza. Rientrato a Parigi, scrive "Le Sourcier de Meudon", dedicato a Madame de Balzac. Il 21 agosto 1861, la Massoneria gli conferisce il grado di maestro. Durante la presentazione di un lavoro in Loggia sui misteri dell’iniziazione, viene confutato da un Fratello, il professor Ganeval. Éliphas, abituato ormai alla deferenza e a non essere contraddetto, lascia la Loggia e la Massoneria. Falliti tutti i tentativi di fargli cambiare idea, nel 1865 la Loggia di Éliphas, intitolata Rose du Parfait Silence, cade interamente in sonno; e c’è chi - come Oswald Wirth - vede nell’evento una relazione di causa effetto con l’abbandono di Éliphas. Constant, del resto, motiva la sua decisione con l’impossibilità di condividere la deriva anti-cattolica della Massoneria. Il 29 agosto del 1862 edita "Faubles et Symboles", opera essenziale sul simbolismo, in cui analizza nel dettaglio i simboli del pitagorismo, dei Vangeli apocrifi e del Talmud.
Intanto frequenta i circoli dello spiritismo, più che altro per documentarsi sul fenomeno. Nel 1863 muore Louis Lucas, un chimico iniziato all’ermetismo e all’alchimia, discepolo di Wronski ed amico di Éliphas. Nel 1865, Éliphas scrive un nuovo libro sui simboli "La Science des Esprits".
Nell’estate dello stesso anno, il suo editore gli chiede di scrivere un trattato sulla Cabbala. Éliphas si dedica a tempo pieno alla stesura di "Les Livre des Splendeurs", incentrato principalmente sulla qabbalah dello Zohar, che uscirà postumo. In questo periodo inizia a soffrire di forti emicranie. Nel 1870, essendo state interrotte le comunicazioni con la provincia, riceve con difficoltà i sussidi dai suoi allievi. Mentre presta servizio come Guardia Nazionale, gli viene diagnosticata una malattia cardiaca. Terminati i moti e le agitazioni comunitari, trova ospitalità da un’allieva, Mme Gebhard, che abitava a Elberfeld in Germania. Durante il soggiorno tedesco scrive "Les Portes de l’Avenir". Ritornato a Parigi, apprende della morte della baronessa Spedalieri, che aveva gettato il marito in una forte crisi spirituale, facendolo diventare ateo e materialista. Nel dicembre del 1871, Éliphas scrive un libro su riti massonici: "Le Grimoire Franco-Latomorum". Nell’autunno del 1872, Noèmi, la sua ex-moglie, divenuta scrittrice e scultrice affermata, si risposa con un deputato di Marsiglia, candidato a diventare ministro del commercio. Intanto la salute di Éliphas continua a peggiorare. Soffre di una patologia cardiaca, che lo porta sovente a svenire; Éliphas crede di avere avuto, durante questi svenimenti, delle visioni estatiche. Nel novembre 1873, Judith Mendès, figlia di Gautier, si rivolge ad Éliphas per avere delle informazioni sulla Cabbala, che possano servire alla lavorazione del romanzo che sta scrivendo. Éliphas si reca a casa del padre della ragazza, a cui legge la mano predicendole grandi successi per l’avvenire. Il marito di Judith fa conoscere Victor Hugo ad Éliphas. Nel 1874, una bronchite persistente, unita a un gonfiore alle gambe, mette a dura prova la sua salute. Il 31 maggio 1875, Éliphas si spegne all’età di 65 anni. Seppellito al cimitero d’Ivry, nel 1881 i suoi resti sono riesumati e gettati in una fossa comune.

![]()

Sul Pensiero e l’Opera di Éliphas Lévi
Eliphas Lévi fu un ricercatore dotato di una vastissima
erudizione, che amava indossare le vesti del grande iniziato, senza decidersi
tuttavia ad esserlo veramente. Se consideriamo, ad esempio, l’episodio
dell’evocazione dello spirito di Apollonio di Tirana, con la conseguente
rinuncia alla magia operativa formalizzata anche in un giuramento per gli
allievi, così come il tentativo di minimizzare e non dare seguito al sogno
premonitore, si ha l’esatta dimensione di un uomo che distillava le sue
convinzioni più sui libri, di quanto non facesse nella vita quotidiana. Éliphas
Lévi fu anzitutto un teorico, più che un operatore alla Crowley; e del resto la
sua vicenda non è stata caratterizzata dall’interesse esclusivo per la
philosophia occulta, ma piuttosto da variegate passioni che ne hanno
contrassegnato l’evoluzione del pensiero. Dal sacerdozio all’occultismo,
passando per la politica: un cammino esistenziale alquanto travagliato, più che
una scelta di vita vera e propria. Éliphas Lévi, del resto non aveva alcun
problema a mettersi nei panni dello studioso che assembla documenti ed
informazioni variegate e disparate, perché era in grado di amalgamare
ecletticamente nei suoi libri il profluvio dei dati. Egli aveva la mentalità del
sincretista, ma non del sistematico: un tratto comune a molti, se non a tutti,
gli occultisti moderni.
Il sincretismo di Éliphas Lévi appare chiaramente in un breve
scritto dall’incerta datazione "Magia delle Campagne e Stregoneria dei Pastori"
in cui egli disquisisce su come alcuni frammenti di antiche credenze
pagano-cristiane siano confluiti nella forma del folklore e della superstizione
rurale. L’analisi di Éliphas appare subito abbastanza incerta tra il
soprannaturale e la spiegazione scientifica, ondeggia curiosamente senza mai
prendere una risoluzione in favore dell’uno o dell’altra, ed alla fine tenta di
conciliare tra di loro i due corni del dilemma. Possiamo intravedere queste
difficoltà già nelle riserve con cui Lévi avvisa che queste formule ingenue e
travisate dalla superstizione - simulacri deformati di un probabile antico
sapere - possono non essere del tutto attendibili. Salvo poi, quasi a
compensare l’inattesa professione di scetticismo, affermare subito dopo che la
loro efficacia dipende dalla fede dell’orante. Non ci è dato sapere
quindi, come la pensi davvero Éliphas Lévi, se il suo pensiero protenda verso
una forma di realismo o di volontarismo magico. Il trattato si apre con una
descrizione generica dei disturbi psicocinetici che colpiscono gli uomini delle
campagne.
Nella solitudine, in mezzo al lavoro della vegetazione, le
forze istintive e magnetiche dell’uomo aumentano e si esaltano, le forti
esaltazioni degli umori degli alberi, l’odore dei fieni, gli aromi di certi
fiori riempiono l’aria di ebbrezza e di vertigine; allora le persone
impressionabili cadono facilmente in una specie di estasi che le fa sognare
da svegli.
È allora che, secondo Lévi, uccelli notturni,
lupi mannari e folletti, tormentano ripetutamente i contadini.
Tuttavia, Éliphas Lévi ci ammonisce sull’attendibilità di queste visioni che “sono
reali e terribili, e non bisogna ridere dei nostri vecchi contadini bretoni
quando raccontano ciò che han visto”. Questi fenomeni sono causati, secondo
Éliphas Lévi, da una sorta di magnetismo naturale, dovuto a turbini magnetici,
che “operano prodigi simili a quelli dell’elettricità, come l’attrazione o la
repulsione degli oggetti inerti, delle correnti atmosferiche, nonché
influenze simpatiche o antipatiche pronunziatissime (sic)”. È evidente, nel
passo sopra riportato, l’influenza esercitata dal mesmerismo sul pensiero di
Lévi. Il mesmerismo, lo studio del magnetismo naturale, era all’epoca una
dottrina che cercava di darsi una parvenza di criteriologia sperimentale per
essere accettata nelle Accademie. Riferendosi ad essa, Éliphas Lévi
evidentemente si propone di avallare le sue spiegazioni con le teorie di
questa probabile nuova disciplina scientifica. Tuttavia, persistendo nella sua
attitudine sincretista, non si limita ad un discorso scientifico, ma
prova ad amalgamare il mesmerismo con il kardecismo e con delle suggestioni
animistiche. Éliphas Lévi si sforza di articolare questa commistione adattandola
alla gergalità scientifica dell’epoca, con il risultato di continuare
nell’oscillazione interna alla dicotomia scienza-arcano, piuttosto che tentare
di superarla nell’armonia di una qualsiasi Aufhebung pacificatrice. Appare
evidente il tentativo di Éliphas Lévi di conciliare il sovrannaturale con la
scienza moderna. Del resto questo sincretismo è peculiare a tutti gli occultisti
moderni; ma è soprattutto con quelli del XIX secolo che si manifesta la
propensione a dimostrare come queste teorie possano convivere con gli assunti
della scienza, senza per questo uscirne ridimensionate o reinterpretate.
Per Lévi la causa di quelle strane malattie contagiose che
colpiscono i greggi, deve essere ricercata nei “patti”, ricettacoli di
malefici, orditi da pastori rivali e sotterrati nei pressi delle stalle che
s’intendono colpire. Secondo Éliphas Lévi la scienza è adesso in grado di
dimostrare la plausibilità di ciò che si riteneva mera superstizione. Tuttavia,
se l’intento dell’autore è palesemente quello di superare la dicotomia
scienza-fede, egli fallisce in pieno: non riesce ad elaborare una teoria
plausibile e l’unico risultato che ottiene è quello di continuare
nell’oscillazione alternata verso i due corni del dilemma. In altre parole,
Éliphas Lévi non riesce a dare un fondamento scientifico alle superstizioni ed
alle credenze, perché probabilmente non si cala fino in fondo nell’abito dello
scienziato, finendo, viceversa, per ricadere sempre nel corto circuito
dell’occultista che postula la conoscenza scientifica sugli assunti
dell’immaginale o degli assiomi metafisici. Ad esempio, sempre nello
scritto sulla magia delle campagne, Lévi azzarda un tentativo di spiegazione
scientifica sulla base dei postulati del mesmerismo, sostenendo che l’influenza
magnetica dell’uomo, indirizzata dalla volontà, è in grado di attaccare
qualsiasi oggetto, anche distante. Il risultato sarà tanto più favorevole quanto
la volontà dell’uomo è addestrata ed esercitata specialmente ad impressionare
l’immaginazione. Di fronte, a simili attacchi magnetici, gli animali non possono
resistere a lungo, mentre il libero arbitrio umano può in ogni caso fungere da
punto di resistenza. Sorprendentemente, nel passo successivo, Éliphas Lévi
anziché continuare ad elaborare la sua teoria cercando di strutturarla secondo
una qualche parvenza di scientificità, decide di sottrarsi alle difficoltà con
una netta oscillazione verso il magico:
"Vediamo intanto come gli stregoni di
campagna compongono i loro malefizi, veri patti con lo spirito di perversità, i
quali servono di consacrazione fatale alla loro volontà malvagia. Essi formano
un composto di sostanze che non si possono procurare senza colpe ed unire senza
sacrilegio; pronunziano su questi orribili miscele delle formule di esecrazione
e sotterrano nei campi del loro nemico o sotto la soglia della porta della sua
stalla, questi segni di un odio infernale."
Éliphas Lévi ha appena introdotto una spiegazione della magia
su basi scientifiche, ed adesso ripiega su termini come
spirito di perversità, sacrilegio, orribili miscele ed
odio infernale. Ha abbandonato il campo della ricerca scientifica per
ritornare ad usare espressioni da romanziere gotico. Ciò non impedisce a Lévi di
postulare che il padrone del gregge colpito possa ritardare l’attacco, qualora
opponga una resistenza energica al magnetismo. A questo proposito è essenziale
la concentrazione collettiva della volontà, ottenuta con l’aiuto dei vicini e
degli amici della vittima. Se la cooperazione energetica riesce, il maleficio
ritorna al mandante, che subisce, in questo caso, gli effetti dell’attacco da
lui stesso ordito: l’unica salvezza è adesso il dissotterramento del “patto”.
A questo punto del trattato, Éliphas Lévi introduce
repentinamente una digressione erudita, illustrando le tecniche utilizzate nel
Medioevo per proteggere le stalle, tra le quali spicca la pratica del sale
magnetizzato da esorcismi speciali. Éliphas non prova minimamente a
cimentarsi in una qualunque spiegazione su come si ottenga la magnetizzazione
del sale: si preoccupa piuttosto, a questo punto, di introdurre una serie di
esorcismi, apparsa già nella Chiave dei Grandi Misteri, prodigandosi di
ricordare come la trasmissione orale possa avere alterato le formule originarie.
Dopo aver riportato per esteso l’orazione denominata Il Castello di Bella, la
compara con la formula originaria, non mancando di sottolineare il grado di
alterazione ridicola dei “piccoli libri volgari di stregoneria e di pretesa
magia che si osa ancora divulgare nelle campagne” . Tuttavia,
immediatamente, ammonisce i falsi sapienti, ossia i moderni, di non ridere di “questi
rustici incantatori”, che compivano le loro orazioni sul sale, perché:
"Essi sapevano bene quello che facevano
e il loro istinto, diretto dall’esperienza, li guidava più sicuramente di quanto
non avrebbe potuto farlo tutta la povera scienza di quel tempo. Oggi che la fede
d’una volta si è affievolita nelle campagne, queste ingenue orazioni non hanno
più potenza né prestigio". In questo passo possiamo cogliere un chiaro
esempio del sincretismo di Lévi. Egli rivendica il valore della vivida fede in
grado di trasmutare la materia, operando in questo caso sulla salute del gregge:
un caposaldo del pensiero esoterico e magico. Ciò nonostante poco prima ha
appena finito di stigmatizzare l’alterazione ridicola dei “piccoli libri
volgari di stregoneria e di pretesa magia”. Se queste formule, recitate con
vivida fede si rivelano efficaci, perché parlare allora di alterazione ridicola?
Se l’effetto è raggiunto comunque, il grado di alterazione può essere rilevante
per il filologo o l’erudito, ma non per l’occultista. Ossia l’alterazione
riguarda casomai la forma letteraria della preghiera, non la sua valenza
operativa. Éliphas Lévi manca del tutto quindi di una qualsiasi metodologia di
studio; ma parimenti difetterebbe anche di concretezza empirica, nel caso
ambisse a presentarsi come esponente della philosophia occulta, e non come un
semplice studioso.
Nella Magia delle campagne e stregoneria dei pastori,
l’occultista francese introduce una serie di preghiere da recitare per ogni
giorno della settimana, non dimenticando, ancora una volta, di richiamare
l’attenzione sulla semplicità delle formule. Éliphas Lévi conclude con il
richiamo allo spirito di comunione rurale, il solo in grado di scongiurare i
malefici; la stessa preghiera collettiva, per Lévi, è molto più efficace di
quella singola, grazie alle correnti magnetiche che si formano all’interno della
catena forgiata da un gruppo. Al contrario, l’individuo isolato è da sempre
molto vulnerabile. Si devono evitare anche i malati cronici, perché portatori di
energie negative; così come, del resto, è preferibile affidarsi a Dio, piuttosto
che agli stregoni e agli indovini. È necessario, per Lévi, se si tiene alla
salute del gregge, evitare l’evocazione dello spirito delle tenebre: per
comandare le forze elementari è sufficiente possedere una grande rettitudine
morale e uno spiccato senso della giustizia. Compito dell’uomo è
l’educazione dell’intelligenza e del libero arbitrio: con l’autocontrollo i
grandi asceti del deserto riuscivano a comandare i leoni e gli orsi. Il trattato
si chiude, infine, con un invito degno di un umanista illuminato, probabile
retaggio della formazione politica dell’autore. Per Lévi il segreto per riuscire
a proteggersi dai malefici, la vera cifra simbolica di ogni rito apotropaico,
risiede nel giusto atteggiamento morale dell’uomo che rispetta la natura, lavora
con scrupolosità, obbedisce alla ragione e sacrifica il proprio interesse
egoistico alla giustizia.
In Il Dogma dell’Alta Magia, Éliphas Lévi riconosce
l’esistenza di una filosofia occulta che sarebbe la nutrice o
madrina di tutte le religioni , di tutte le forze intellettuali, di tutte
le oscurità divine. Questa dottrina primordiale costituisce il tronco
nascosto di tutte le sacre scritture e di tutte le iniziazioni, assurte così a
ramificazioni particolari e contingenti dell’unico albero. Essa germina tutte le
tradizioni iniziatiche e religiose dell’Egitto, dell’India brahmanica, della
Grecia, della Persia; la conoscenza di questa dottrina rende gli adepti in grado
di esercitare un controllo assoluto sulla materia: Lévi racconta che gli uomini
che possedevano questo sapere erano in grado di uccidere o di fare impazzire chi
si lasciava avvincere dal loro prestigio. Ritroviamo qui una delle idee
caratteristiche, ancorché secondarie, dell’esoterismo occidentale. Tuttavia,
Lévi non pensa, diversamente dai perennialisti, alla trasmissione di una verità
trans-storica, perché la dottrina primordiale non è altro che la Cabbala,
arbitrariamente identificata con la scienza dei magi; la cui alleanza originale
con il cristianesimo, è stata disconosciuta per paura ed ignoranza. Riconoscere
questa concordanza significa, per Lévi, riuscire a conciliare la scienza con il
dogma, la ragione con la fede. Del resto, sempre per Lévi, la visita dei re magi
alla culla del Redentore confermerebbe questo primitivo sodalizio tra
Cristianesimo e magia. Éliphas Lévi sostiene che le tracce di quest’alleanza
possono essere ritrovate in due libri, che la Chiesa non riesce in fondo a
capire, ma al contrario perfettamente intelligibili all’iniziato: l’Apocalisse e
la Profezia di Ezechiele. Accenna, tuttavia, anche ad un terzo libro, occulto e
popolare insieme ed ancora più antico di quello di Enoch, nel quale è racchiusa
la chiave di tutti i misteri:
"Si, esiste un segreto formidabile, la
cui rivelazione ha già rovesciato il mondo, come lo attestano le tradizioni
religiose dell’Egitto riassunte simbolicamente da Mosè all’inizio della Genesi.
Questo segreto costituisce la scienza fatale del bene e del male, è il suo
risultato."
Si, esiste un dogma unico, universale, imperituro, forte come
la ragione suprema, semplice come tutto ciò che è grande, intelligibile, come
ciò che è universalmente e assolutamente vero, e questo dogma è stato padre di
tutti gli altri Éliphas Lévi identifica problematicamente questo segreto
formidabile, questo dogma unico, universale, imperituro, con
una serie di rappresentazioni variegate appartenenti a contesti eterogenei: la
materia prima della Grande Opera, il Corpo Igneo dello Spirito Santo, “adorato
anche nelle cerimonie del Sabba o del Tempio, sotto la forma geroglifica del
Bafomet, o del becco androgino di Mendes”. Ma per Lévi, questa chiave di
tutte le allegorie magiche, interessa un gran numero di miti e tradizioni. La
ritroviamo alla radice dell’opera di Ermete, dell’ordine del Toson d’Oro,
dell’Orfismo, e persino del mito di Edipo. La colpa di Edipo è quella di aver
ucciso la Sfinge, invece di dominarla; così come quella di Psiche è di aver
guardato di nascosto il corpo di Eros, invece di persuaderlo a rivelarsi
spontaneamente. L’inganno e la violenza, precludono, secondo Lévi, al
possesso della conoscenza; la quale deve, viceversa, essere padroneggiata
armoniosamente e poi dissimulata:
"il grande segreto magico è dunque la lampada ed il
pugnale di Psiche, il pomo di Eva, il fuoco sacro rubato da Prometeo, lo scettro
ardente di Lucifero; ma è anche la Croce santa del Redentore. Conoscerne tanto
da poterne abusare o da farsene divulgatore, è meritarsi tutti i supplizi;
saperlo come deve essere saputo per servirsene e nasconderlo, è essere maestri
dell’ASSOLUTO".
Éliphas Lévi, dopo aver fatto sfoggio di erudizione ed aver
citato diversi miti come forme distinte e riconducibili all’unico segreto, senza
peraltro essersi scomodato ad impostare il minimo straccio di dimostrazione,
rivela che il libro che “riunisce tutto il genio filosofico e il genio
religioso”, “tesoro cinto di spine, diamante nascosto”, non è altro
che il Talmud. Il Pentateuco, in realtà, è solo un libro elementare; è solo nel
Talmud che si nasconde “la vera filosofia segreta e tradizionale
[...] scritta solo più tardi, sotto veli meno trasparenti ancora. Così nacque
una seconda Bibbia sconosciuta o almeno incompresa dai cristiani”. In questo
libro, sempre secondo Lévi, si nascondono le chiavi di lettura della vera
Cabbala, che si troverebbe alla base delle religioni e della scienza; nella
Cabbala si concilia l’alleanza della ragione con il Verbo e la fede, “il
potere con la libertà, la scienza col mistero, essa ha le chiavi del presente,
del passato e dell’avvenire”.
Secondo Éliphas Lévi, dunque, la Cabbala è il principio e la
radice di tutti i rami della conoscenza; la sua padronanza garantisce il
superamento dell’aporia ragione-fede. Tuttavia l’occultista francese non riesce
a sviluppare le sue asserzioni all’interno di un’esposizione articolata; ed in
quest’introduzione dobbiamo accontentarci di intravedere, soltanto, le
rivelazioni che Lévi sembra prometterci. In effetti, sembra che l’autore cerchi
letteralmente di aumentare la suspense e le aspettative del lettore: ad ogni
asserzione, Lévi fa seguire un’immancabile digressione erudita.
Finalmente, nel primo capitolo "L’Iniziando", inizia
l’esposizione teoretica vera e propria. Lévi incomincia contestando la validità
del cogito cartesiano. Anziché principiare dal “Cogito, ergo sum”,
sarebbe preferibile farlo dall’“Ego sum qui sum”, con cui inizia la
rivelazione divina nell’uomo. Quest’ultima è la manifestazione della ragione
universale a quella umana, è il trait d’union in grado di realizzare
l’Uomo-Dio. Secondo Éliphas Lévi non ha senso sostenere con Descartes che
l’autocoscienza si produce dalla certezza di pensare, perché da quest’ultima
scaturisce piuttosto la dimostrazione dell’esistenza dell’Essere superiore.
Dunque il Verbo divino regala la scintilla del pensiero razionale all’uomo, ma
nello stesso tempo gli si rivela come suo fondamento. Lévi dunque risale
all’esistenza di una Causa prima aristotelica, ma elabora una serie di teorie
del tutto estranee al pensiero dello stagirita. Per Lévi il Verbo è il velo
dell’essere, identificato con l’idea platonica del principio anipotetico
(idea della Verità assoluta, assolutamente indimostrabile). Ma la forma è,
sempre per Lévi, a sua volta il velo del Verbo; quindi l’idea (essere) è la
madre del Verbo e la ragion d’essere della forma. Il velo simboleggia qui la
dissimulazione della realtà segreta; per converso lo svelamento equivale alla
rivelazione, alla conoscenza. Per Lévi è quindi l’idea a strutturare la forma,
secondo il principio delle corrispondenze espresso dalla Tavola Smeraldina “Ciò
che è in alto è come ciò che è in basso, ciò che è in basso è come ciò che è in
alto”. La forma è dunque proporzionale all’idea, dato che quest’ultima è la
matrice del Verbo e del mondo formale e materiale. Il fodero è in proporzione
con la lunghezza della lama, la negazione con l’affermazione, la produzione con
la distruzione, l’ombra del corpo con l’intensità dei raggi luminosi. Ma se è
vero che possedere l’idea significa plasmare la forma, allora in virtù della
rivelazione del Verbo divino “Sono colui che sono”, l’uomo deve avere il
potere latente di padroneggiare l’immaginazione che forgia la materia. Grazie al
Verbo, l’uomo può rendere la propria immaginazione in grado di vivificare le
forme, arrivando - sempre secondo Lévi - a guarire le malattie, influenzare le
stagioni, risuscitare i morti.
Quindi se l’immaginazione è in grado di ricollegare il
pensatore all’idea suprema, o se si preferisce all’essere, per Lévi è evidente
l’unità di una sola ragione, di una sola filosofia. Questo principio unico che
Lévi chiama “Dogma”, non è altro che l’identità tautologica dell’essere
con se stesso, che si concretizza in una metafisica monista. Il divenire, i
fenomeni visibili diventano allora manifestazione dell’invisibile. Il principio
supremo che determina gli enti transeunti, nel suo "Dogma dell’Alta Magia", è in
altre parole l’identità autoreferenziale dell’essere. Su come possa realizzarsi
questa determinazione del visibile assumendo il postulato del circolo vizioso
dell’identità che contempla se stessa, non ci viene fornita, per il momento,
alcuna delucidazione teoretica: ma è verosimile pensare che Éliphas Lévi dovesse
conoscere l’idealismo tedesco, la filosofia di Fichte, Hegel, Schelling.
Infatti, continuando nella nostra lettura, il secondo paragrafo dopo essersi
aperto con la curiosa distinzione tra scienza e gnosi - il possesso completo
della verità concerne solo la scienza, mentre alla gnosi è riservata solo
un’intuizione priva di conoscenza effettiva - Éliphas entra
timidamente nel dettaglio e mostra di possedere qualche rudimento
sull’idealismo. Conoscenze acquisite probabilmente nel periodo giovanile degli
studi in seminario; a questo proposito si deve rammentare l’enorme impatto
dell’idealismo, specialmente del pensiero di Hegel, sulla teologia e la
filosofia della religione. Tuttavia, alla presunta conoscenza della dialettica
hegeliana, si deve aggiungere anche la più sicura padronanza di Lévi della
teoria cabbalistica sull’emanazione delle Sefirot. Tutte e due i sistemi di
pensieri, dialettica hegeliana e Cabbala, forniscono una spiegazione di come
possa scaturire dall’identità la differenza -
ossia gli altri numeri dall’uno - senza trascurare nemmeno la possibilità
che Lévi avesse letto Fichte, autore, tra l’altro, come lui legato alla
Massoneria. Purtroppo per il momento, in assenza di ulteriori informazioni, non
è possibile svelare con certezza quali siano state le fonti filosofiche di
Éliphas Lévi, e siamo costretti a muoverci sul terreno delle ipotesi; fermo
restando la certezza della sua competenza cabbalistica.
Lévi si addentra quindi all’interno della numerologia
cabbalistica. La conoscenza suppone, per Lévi, il rapporto binario
conoscente/conosciuto. L’unità che crea si moltiplica per se stessa
producendo il binario, così come Eva si genera dal petto di Adamo. Quest’ultimo
è rappresentato dalla singola lettera Jod, mentre il nome Eva ne contiene tre.
Jehova si genera allora dall’unione di Adamo, Jod, ed Eva: anzi per Lévi
sarebbe più corretto pronunciare il nome di Dio come Ieva, così composto
da quattro lettere. La trascrizione cabbalistica del nome di Dio, è il
tetragramma divino, parola magica per eccellenza. Ne deriva, per Éliphas Lévi,
che il numero quattro è la chiave di tutti i numeri e di tutte le forme. Éliphas
Lévi arriva a questa conclusione soffermandosi prima sul binario - da lui
identificato con le colonne del tempio e la gnosi - e poi sul ternario,
raffigurato dal triangolo di Salomone e dalla physis. Lévi richiama una serie di
sistemi dicotomici uomo/principio/attivo/unità/Bohas/Yang - donna/Verbo/
passivo/Jakin/Yin esprimenti l’ambivalenza del fenomenico, e ricorda come
tutto sia essenzialmente un gioco tra un principio attivo ed uno passivo. Tutto
è riconducibile a questi due principi, determinati dalla necessità e libertà
dell’unità divina creatrice. L’unità ha bisogno di estrinsecare dalla propria
indeterminatezza un elemento contrapposto da superare, il progresso del divenire
è la risultante di questo superamento dialettico infinito: “ in Dio il
binario esiste solo per mezzo del ternario; se concepite l’assoluto come
dualità, è necessario immediatamente concepirlo come trinità, per ritrovare
l’unità ”.
Il Ternario, dunque per Éliphas Lévi, è l’immagine stessa
della perfezione del cosmo, perché presuppone “ un principio intelligente, un
principio parlante ed un principio parlato ”, in altre parole il Creatore,
il Cosmo, il Verbo; o ancora la Persona che parla, quella a cui si parla, e
quello di cui si parla: “ L’assoluto, che per mezzo della parola si rivela,
le dà un senso a lui eguale e nell’intelligenza di questa parola crea un terzo
se stesso ”. L’importanza del ternario è simboleggiata dal Triangolo di
Salomone, secondo le due varianti con il vertice in alto e la base in
basso, e viceversa; la sintesi di questi due triangoli forma la Stella di David.
L’emanazione del Principio che crea, trasmettendo se stesso a se stesso, è
anche, sempre secondo Lévi, alla radice del mistero trinitario. Ciò che è trino
è Uno, ma è trino per la necessità di creare; tuttavia se è vero che il binario
è generato dall’Uno, deve giocoforza possedere la stessa essenza divina: quindi,
la Trinità esprime e racchiude il cerchio perfetto della creazione come sintesi
dei due momenti. Del resto, sempre per Lévi, anche le leggi dell’attrazione
sessuale esprimono la necessità di generare il tre attraverso l’unione delle
singole unità. Il ternario è la rappresentazione della forza universale
dell’amore che vuole riprodurre la vita attraverso se stessa:
" l’unità per divenire attiva deve moltiplicarsi. Un
principio indivisibile, immobile ed infecondo, sarebbe l’unità morta ed
incomprensibile. Se Dio non fosse che uno, non sarebbe mai creatura né padre; se
fosse due vi sarebbe antagonismo o divisione nell’infinito, e sarebbe la
ripartizione o la morte di ogni cosa possibile: è dunque trino per creare egli
stesso e a sua immagine la moltitudine degli esseri e dei numeri. Dunque il tre
è espressione dell’amore universale e divino, perché si pone come sintesi
armonica tra i contrapposti. Ma tre sono anche, sempre per Lévi, i piani
metafisici del reale, gerarchicamente ripartiti in un piano fisico, in uno
spirituale ed in uno divino. Tutto possiede un triplice senso, tanto le
azioni quanto le idee " ; così Éliphas Lévi svela che il vero dogma
fondamentale del Cristianesimo non è altro che questo principio ternario della
Cabbala, in grado di ristabilire l’unità conciliando armonicamente il dualismo
apparente. Il mistero della Trinità è spiegato attraverso il ternario
cabbalistico; ed in particolare nella formula del Vangelo secondo Marco: “
Poiché tuo è il regno e la potenza e la gloria in sempiterno ”, si cela
sinteticamente la chiave fondamentale.
Éliphas Lévi dimostra qui una certa carenza di analisi, o
perlomeno una buona dose di ingenuità. Lévi tralascia o finge d’ignorare
quello che aveva precedentemente asserito, e cioè che il dogma fondamentale
non è altro che l’identità tautologica dell’essere con se stesso, per aggiungere
invece adesso che si tratta del principio ternario. Non sussisterebbe nessuna
difficoltà, se solo si soffermasse a spiegare come il divenire triadico coincida
con l’evoluzione del principio identitario, che vuole sfuggire
all’autoreferenzialità. Ma ogni qual volta che le circostanze del discorso
richiedono il ricorso all’analisi teoretica, Lévi si sottrae e preferisce
continuare a divagare con osservazioni erudite. Così troppo spesso Lévi si
accontenta di accennare, ed il senso deve mettercelo il lettore. Un altro limite
dell’occultista francese è che usa gli stessi termini con significati diversi a
seconda del contesto, senza preoccuparsi di specificare ogni volta quale sia il
senso semantico. Ad esempio, Lévi ha usato ripetutamente il termine
“dogma”, attribuendogli due diversi significati - la tautologia dell’essere ed
anche il principio ternario - tuttavia il significante rimane pur sempre
uno “dogma”. Senza nessuna spiegazione, leggiamo alla fine del capitolo che il
dogma si è triplicato: “ la virtù segreta degli
evangeli è dunque contenuta in tre parole e queste parole hanno fondato tre
dogmi e tre gerarchie
” . È questo un esempio significativo sulla genericità semantica in cui
sembra incorrere l’autore francese, perché sarebbe stato più corretto asserire,
in base a quanto egli stesso aveva finora scritto, che il principio ha tre
emanazioni, o che il dogma si estrinseca in tre dogmi secondari. Lévi invece
sembra non curarsi di queste sottigliezze, né tantomeno di fornire spiegazioni.
Éliphas Lévi dopo essersi soffermato sull’importanza del
principio triadico, introduce ora il tetragramma, descritto come l’addizione
dell’idea dell’unità al ternario:
" Vi sono nella natura due forze che producono un
equilibrio, e le tre non sono che una legge sola. Ecco come il ternario si
riassume nell’unità, e aggiungendo al ternario l’idea d’unità, si giunge al
quaternario, primo numero quadrato e perfetto, fonte di tutte le combinazioni
numeriche e principio di tutte le forme ". Anche questo passaggio è molto
confuso. Lévi non spiega la ragione per cui alle tre forze - i contrapposti più
la risultante - si dovrebbe aggiungere l’idea dell’unità; o forse è preferibile
ipotizzare che egli tenta di abbozzare una spiegazione che, purtroppo per lui,
non convince. Infatti, Lévi, ritornando sul mistero della Trinità, aggiunge che
le tre Persone sono emanazioni o manifestazioni dell’unico Dio; ma da
quest’argomento ne trae una conclusione alquanto bizzarra: “ Tre ed uno danno
l’idea del quattro poiché l’unità è necessaria per dare spiegazione del tre
”. L’eventualità che le tre Persone siano equivalenti all’Unità, non comporta
certamente che il numero delle stesse debba incrementarsi, perché l’Uno è
solamente la risultante di un rapporto intrinseco alla Trinità e non un’essenza
spirituale o metafisica. Così come è discutibile la sua argomentazione che
“
l’affermazione dell’unità suppone il numero quattro, se l’unità non rientra
in se stessa come in un circolo vizioso. E pure il ternario, come già detto, si
spiega col binario e si risolve col quaternario ”; o anche, “ la parola
perfetta, quella che è adeguata al pensiero che esprime, contiene sempre
virtualmente o suppone un quaternario: l’idea e le sue tre forme necessarie e
correlative, poi l’immagine della cosa espressa con i tre termini del giudizio
che la qualifica
”. Éliphas Lévi, insomma, cade vittima di un realismo infantile che gli fa
scambiare dei semplici rapporti logici per delle entità ideali. Del resto,
questi non sono i soli esempi delle difficoltà che Éliphas Lévi incontra quando
si cimenta nelle sue speculazioni. Continuando nella sua dissertazione sul
tetragramma, egli repentinamente enuncia che “due” affermazioni rendono
necessarie “due” negazioni. Secondo quanto l’autore francese ha finora spiegato,
non ci sarebbe stato nulla da eccepire se si fosse limitato a sostenere che
un’affermazione rende necessaria una negazione. Non si capisce, viceversa, le
ragioni di quest’arbitrario raddoppio dei contrapposti, se non con la
motivazione di inventarsi una giustificazione metafisica al quaternario.
Rimane il fatto, che l’impianto teoretico del Dogma dell’Alta
Magia è alquanto lacunoso e sfilacciato.
La profezia cristiana, per Lévi, è segnata da quattro tappe.
La prima, segna la venuta di Cristo e la disgregazione del politeismo; la
seconda, prevede l’avvento dell’Anticristo; la terza, la caduta dell’Anticristo
e il ritorno della virtù cristiana nell’Occidente; la quarta e definitiva, il
secondo avvento di Cristo ed il giudizio finale. Non ci sarebbe nulla da
obiettare, se Lévi non se ne uscisse con questo sbalorditivo passaggio: “
questa quadruplice profezia contiene, come è possibile costatare, due
affermazioni e due negazioni, la idea di due rovine o morti universali e di due
rinascite ”. Secondo Lévi, dunque la terza fase sarebbe in tutto e per tutto
negativa al pari della seconda. Anche ipotizzando l’eventualità, alquanto
remota, che Lévi durante la sua vita sia venuto in contatto con qualche nuova
religione millenaristica dell’area giudaico-cristiana, si dovrebbe in ogni caso
costatare come nessuna di queste abbia mai descritto la terza fase come negativa
o “rovinosa”, ma tutt’al più come “aurora” e preludio dell’avvento del regno di
Dio sulla terra.
Anche la vita umana è segnata, per Lévi, da tre (quattro)
fasi, la nascita, la vita, la morte e l’immortalità. Seguono una serie di
considerazioni dalla chiara impronta “parmenidea”, in cui Éliphas Lévi sostiene
che “ la nascita prova la preesistenza dell’essere umano, giacché nulla
nasce dal nulla, mentre la morte prova l’immortalità, giacché l’essere non può
cessare d’essere più che il nulla non possa cessare di non essere ”. Éliphas
Lévi continuando a saltare da un argomento all’altro, nel suo tipico stile
farraginoso, arriva, infine, ad una quadripartizione degli elementi magici e
degli spiriti elementari. Prendendo spunto dalla conformazione di una croce, al
nord sono collocati l’azoto, l’aquila, l’aria; ad ovest, il
mercurio, l’uomo, l’acqua; a sud, il sale, il toro, la terra; ad est,
lo zolfo, il leone, il fuoco. L’aria e la terra, poiché sono sull’asse verticale
rappresentano il principio maschile; il fuoco e l’acqua, su quello orizzontale,
il femminile. Segue la comparazione degli elementi alle quattro “idee”
filosofiche spirito, materia, moto, inerzia, che l’alchimia riduce a tre
assoluto, l’immobile, il volatile. " Compito degli spiriti creati è
ricercare e rimanere sul centro della croce, punto d’equilibrio statico della
libertà dalle passioni. Viceversa, chi oscilla incessantemente tra le
quattro estremità della croce è destinato a rinascere in vite animali o
demoniache. Gli uomini viziosi sono dunque condannati a reincarnarsi in silfidi,
ondine, gnomi, e salamandre." Finalmente Lévi riesce ad elaborare un sistema
immaginale che non contrasta palesemente con le tradizioni mitiche, o con quanto
da lui stesso precedentemente scritto. Esiste un “centro” che è il topos della
temperanza e dello spirito, cui si contrappongono i quattro vertici cardinali,
interpretati come raffigurazioni delle passioni estreme e del caos. Tutto questo
può essere filosoficamente discutibile, ma trova riscontri culturali all’interno
della storia delle credenze religiose o delle correnti esoteriche occidentali.
Ed il nostro scopo non è certamente quello di verificare ontologicamente la
dottrina di Éliphas Lévi, ma di approntarne l’analisi storico-critica,
relativamente al contesto culturale e al pensiero espresso dall’autore.
Con il pentagramma, per Éliphas Lévi, si passa dalla teoria
all’empiria. Il pentagramma permette di dominare gli elementi e i demoni
dell’aria, gli spiriti del fuoco, ecc. Il passaggio dal tetragramma al
pentagramma è ottenuto dall’aumento di un’unità; ma diversamente da quello dal
ternario al quaternario ha un senso e un significato sotteso al dominio degli
angeli e dei demoni. Il fine empirico giustifica, quindi, la presenza del
pentagramma, e non costringe Lévi ad arrampicarsi sugli specchi con improbabili
speculazioni illogiche. Il pentagramma è dunque uno strumento con il
quale l’iniziato può sviluppare il controllo della forze della natura, ma anche
l’ occhio dell’anima. Partendo dalla raffigurazione del pentagramma,
Lévi enuncia una serie di postulati sul corpo grossolano e sulla perfetta
adeguatezza dell’anima a percepire gli enti spirituali. Facendo propri gli
assunti orfici e pitagorici sulla dicotomia anima/corpo, Lévi ripropone
l’immagine del corpo come “scorza” dell’anima. Il corpo grossolano non è adatto
a percepire le “cose” dello spirito, ma soltanto l’anima potenziata dallo
sviluppo dell’immaginazione è in grado di percepire la verità e di distinguerla
dall’illusione. Soltanto l’immaginazione “ diafana ” dell’adepto può
percepire la luce cristallina della verità, viceversa nel “volgo” essa arriva “
piena di scorie e di impurità ”. L’iniziato deve quindi riuscire
a distinguere i raggi diretti della verità, dai meri riflessi che provocano
sogni ed illusioni: è evidente in questa concezione il richiamo al mito
della caverna di Platone. Il profano, come il prigioniero della caverna, non può
vedere altro che delle ombre riflesse, simbolo del fenomenico; soltanto la
risalita alla superficie assicura la possibilità di osservare direttamente le
cose alla luce del sole, senza doverle più scambiare per riflessi ed ombre.
Per Lévi, la luce primordiale, emanando le forme dalle idee,
trattiene i riflessi delle prime e costituisce la luce astrale - il “grande
agente magico” - sul quale si può esercitare il potere del pentagramma. La
luce emana le idee divine, ma non può fare a meno di alterarle ed appannarle,
mentre queste attraversano i tre piani metafisici dell’essere. Le forme alterate
delle idee originali s’imprimono come riflessi sulla luce astrale - ma data la
corrispondenza originale delle forme all’idea - padroneggiare le prime vuol dire
influire attivamente sulle seconde. L’attività onirica, per Lévi, è il
risultato della luce astrale; nel sogno lucido si può riuscire a controllare le
immagini, altrimenti vaghe ed incoerenti, ed imparare ad esercitare il potere
dell’immaginazione sulla luce astrale. Il magnetismo animale è quindi una sorta
di sonno artificiale indotto da una volontà esterna sul sognatore. Riuscire
nell’arte magica, per Lévi, significa riuscire ad autoindursi e a controllare
questo stato di sonno magnetico, che ha la sua perfezione nel potere della
chiaroveggenza, Mag? ... La storia delle religioni ha per molto
tempo speculato sull’importanza del sogno come origine del fenomeno
religioso; in particolare questa teoria ha costituito la fortuna della
cosiddetta scuola “animistica”, senza dimenticare il rilievo conferito ai
livelli di coscienza nelle dottrine orientali, ad esempio nelle Upanisad. Lévi
quindi si appoggia alle teorie scientifiche dell’epoca - ma assecondando la sua
mentalità sincretista - non esita ad incrociarle con gli assunti della
philosophia occulta. È il pentagramma che assicura, sempre per l’autore, il
dominio della volontà sulla luce astrale. Il pentagramma garantisce la signoria
sugli spiriti, sia durante lo stato di sonno che di veglia. Il pentagramma è
però anche in grado di “ misurare le proporzioni esatte del grande ed unico
atanor necessario alla formazione della pietra filosofale e al compimento della
Grande Opera ”. In altre parole, il pentagramma dona all’adepto la facoltà
di controllare le forze oscure e spirituali del mondo sensibile. Ma, al
contempo, per dominare queste entità si deve riuscire a resistere alle forze
della natura. Per Lévi solo lo smascheramento dell’illusorietà dei riflessi
della luce astrale, permette di sfuggire al giogo delle forze brutali della
materia. A questo proposito, l’autore distingue la luce umana, da quella astrale
e dal magnetismo universale. La luce umana, secondo Lévi, deve essere
subordinata all’intelligenza, sottomessa all’immaginazione e fatta dipendere
dalla volontà. Quando questo realizza, si produce l’interrelazione del
macro-microcosmo, e l’operatore che assorbe nello spirito e nel corpo gli umori
dell’ambiente, irradia contemporaneamente all’esterno i suoi miasmi e le
sue molecole invisibili. L’attrazione amorosa si produce proprio quando due
individui di sesso opposto interagiscono tra di loro e all’attrazione dell’uno
corrisponde l’espansione dell’altro. Da questa sorta di sinapsi emotiva si
realizza allora il sentimento dell’amore, che genera quell’ebbrezza e quello
stordimento, che il mago - maestro dell’autocontrollo - deve categoricamente
fuggire. Lévi raffigura la luce astrale con l’immagine del serpente della
Genesi, il seduttore universale, “ sempre sovrabbondante di vigore, sempre
fiorito di sogni seducenti e di dolci immagini […] forza cieca per sé stessa e
sommessa a tutte le volontà ”. La luce astrale è lo strumento della vita e
dell’essere, il torrente delle pulsioni animali, il nemico da sconfiggere con
l’iniziazione. Proprio perché la luce astrale con i suoi riflessi sollecita gli
istinti bestiali ed il caos, essa ottenebra l’intelligenza umana che non può
scrutare la fiamma della sapienza divina. Per Lévi all’iniziazione spetta il
compito di restaurare l’ordine corretto di tutte le cose; ma all’iniziato sono
indispensabili la tranquillità del cuore e dello spirito, così
come una
volontà
inflessibile. Ma la temperanza non deve essere ricercata esclusivamente
nell’interiorità dell’adepto: un certo equilibrio oggettivo è indispensabile
alla buona riuscita delle operazioni magiche. Il senario cabbalistico esprime
l’equilibrio magico che si realizza quando la libertà dell’uomo si coniuga con
la volontà di Dio. Per Lévi la libertà dell’uomo ha senso solo se asseconda il
volere divino; sono stati versati fiumi d’inchiostro dai filosofi di tutte le
epoche per risolvere l’annoso problema della libertà umana e della
predestinazione divina. Tuttavia Lévi si infila volutamente e maldestramente in
un’aporia quando definisce l’onnipotenza come “ la libertà più assoluta, che
non può esistere senza un perfetto equilibrio ”. Prescindendo da
quest’ultima ingenuità, l’equilibrio magico di Lévi si concretizza nel
presupposto dell’esistenza di un’armonia cosmica, in cui tutto quello che accade
trova un senso, un significato. L’idea di una corrispondenza universale,
espressa dalla Tavola Smeraldina, trova qui la sua estensione morale in una
teogonia. Per Lévi, il sette è il numero cabbalistico, che meglio di
qualunque altro, esprime la realizzazione della concordia cosmica, in quanto
formato dall’unione del ternario e del quaternario. Sette sono i pianeti che
dominano il tempo dell’esistenza umana: il Sole infanzia, la Luna
adolescenza, Marte e Venere
prima giovinezza, Mercurio virilità, o seconda giovinezza, Giove
età della maturità, Saturno vecchiaia. I Pianeti corrispondono
ad angeli, colori, note musicali, animali: tutti classificati in sette unità. Il
sette è dunque, secondo l’autore francese, il numero magico per eccellenza -
indipendentemente da tutta la magniloquenza usata nella descrizione dei numeri
precedenti - imputabile forse alla scarsa capacità di analisi ed allo stile
eccessivamente enfatico dell’esposizione.
Il numero otto è invece per Lévi il segno della
realizzazione; perché nella philosophia occulta non esistono dottrine
o rituali veridici nella teoria, che non lo siano anche nella prassi. La verità
di una pratica è definita dalla sua applicabilità empirica. Nella magia,
ciò che non si realizza non è. Tutto era stato originariamente creato da Dio
per l’uomo: la stessa luce astrale, prima di diventare la sorgente
dell’illusione sottesa al mondo fenomenico, era lo strumento dell’onnipotenza di
Adamo. Dopo il peccato originale la luce astrale ha iniziato ad intorbidirsi ed
a riflettere i riflessi impuri delle immagini primordiali. Cristo stesso, sempre
secondo Lévi, identificava la luce astrale con Satana, portatore delle
tentazioni del mondo, e predicava la grazia come mezzo mistico per rinnovare il
fluido vitale dell’uomo. I riflessi impuri della luce astrale generano fantasie
insane o pulsioni viziose negli uomini, che a loro volta mediante i respiri
magnetici contribuiscono ad ammorbare ancora di più l’ambiente circostante.
L’anima è come una spugna che assorbe gli influssi dell’atmosfera morale ed
espunge le proprie fantasie proibite. Tutto ciò che noi facciamo, o pensiamo,
resta marcato nella luce astrale ed influenza costantemente non solo il nostro
destino, ma anche quello di chi ci sta vicino. Ecco perché secondo Lévi
nel Cristianesimo riveste una grande importanza il perdono, mentre lanciare
maledizioni è una cattiva azione. L’impopolarità non è altro che una somma di
respiri magnetici ostili, che prima o poi non mancherà di produrre effetti
concreti danneggiando gravemente o mortalmente il diretto interessato. Le
maledizioni e le benedizioni si tramutano quindi in correnti astrali in grado di
uccidere o aiutare l’oggetto su cui sono dirette. La luce astrale, sempre per
Éliphas Lévi, ha anche un’altra importante funzione: al momento della concezione
dell’anima, essa - combinandosi con i fluidi sottili - contribuisce alla
formazione del corpo fluidico o corpo siderale. Alla morte del
corpo fisico, quello siderale trattiene con sé i residui della vita passata, ed
in caso di evocazione spiritica usa gli stessi per manifestarsi ai viventi.
Durante la vita anche il corpo siderale, è sottoposto alle suggestioni dei
riflessi astrali, alle loro attrazioni e repulsioni; secondo Lévi non
necessariamente il corpo siderale è dello stesso sesso di quello terrestre:
quest’eventualità spiegherebbe, secondo Lévi, la psicologia degli omosessuali.
Ovviamente, per Lévi, l’iniziato è al riparo da questi rischi, perché ogni
elemento in lui è perfettamente armonizzato con il tutto. Tre sono i simboli
dell’iniziazione: la lampada di Trismegisto, il mantello di Apollonio e il
bastone dei Patriarchi, che simboleggiano rispettivamente la luce del sapere,
la reticenza mistica, il potere.
Nel discorso un pò sfilacciato del Dogma, Lévi non manca di
mettere in relazione la Cabbala con i Tarocchi. Le dieci Sefirot e i ventidue
Tarocchi formano le trentadue vie della scienza assoluta, le scienze
particolari sono simboleggiate, sempre per Lévi, da cinquanta porte.
L’associazione delle Sefirot: Keter, Chokhmah, Binah, Chesed, Geburah o Din,
Tiferet, Netsah, Hod, Jesod, Malkut con i ventidue Arcani Maggiori:
Il Giocoliere o Bagatto, La Papessa, L’Imperatrice, l’Imperatore, il Papa, gli
Amanti, il Carro, la Giustizia, l’Eremita, la Ruota, la Forza, l’Appiccato, la
Morte, la Temperanza, il Diavolo, la Torre, la Stella, la Luna, il Sole, Il
Giudizio, il Mondo, il Matto, non può del resto compiersi perfettamente -
vista la disparità numerica tra le due serie - ma può riguardare soltanto i
primi dieci arcani: Keter, o Corona con il Bagatto; Chokhmah o Sapienza con la
Papessa; Binah o Intelligenza con l’Imperatrice, ecc.. Per superare
quest’inconveniente, Lévi associa agli Arcani Maggiori tredici chiavi
cabbalistiche e nove
credenze autorizzate dalla religione ebraica, che non sarebbero altro che
trasposizioni “dogmatiche” delle ventidue lettere dell’alfabeto ebraico. Éliphas
Lévi non compie in questo senso un’operazione del tutto nuova alla letteratura
cabbalistica. Per comprendere il significato autentico delle Scritture, la
Cabbala fa sovente uso di tecniche e metodi complessi, che si propongono di
estrapolare un significato mistico dalle lettere dell’alfabeto ebraico e di
attribuirgli un valore numerico. Così al Giocoliere o Bagatto corrisponde il
primo dogma “Tutto annuncia una causa attiva, intelligente”; alla Papessa
il secondo “Il numero serve di prova alla vivente unità”. All’Imperatrice
“Nulla può limitare ciò che tutto contiene”; all’Imperatore “Solo,
prima di ogni principio, è dovunque presente”. Per il Papa “Poiché è il
solo padrone, è il solo che si deve adorare”; per gli Amanti “Ai cuori
puri rivela il suo dogma”. Per il Carro “Occorre un solo capo alle opere
della fede”; per la Giustizia “E' per questo che noi abbiamo un solo
altare, una sola legge”. All’Eternità “Mai l’Eterno cambierà la base”;
per la Ruota “Regola ogni fase dei cieli dei nostri giorni”. Alla Forza
“Ricco in misericordia e potente per punire”; all’Appiccato “Promette
al suo popolo un re nell’avvenire”. Per la Morte “La tomba è passaggio
alla terra novella, la morte è un fine, la vita è immortale”; alla
Temperanza “Il buon angiolo è quello che calma e tempera”; per il Diavolo
“Cattivo lo spirito d’orgoglio e la collera”; alla Torre “Dio comanda
al fulmine e governa il fuoco"; Per la Stella “Vespero e la sua rugiada
obbediscono a Dio”; per la Luna “Egli mette sulle nostre torri la Luna in
sentinella”. Per il Sole “Suo Sole è la sorgente ove tutto si rinnovella”;
per il Giudizio “Il soffio fa germogliare la polvere dei sepolcri”; Per
il Mondo “Ove i mortali scendono a greggi senza freno”; per il Matto “La
sua corona ha coperto il suo propiziatorio”.
Ma Éliphas Lévi intende anche spiegare i segni delle carte.
Il Bastone per lui rappresenta un simbolo fallico o Jod, la Coppa è la vagina,
la Spada è la congiunzione dei due o lingam, inteso qui come axis mundi, unione
del Cielo e della Terra, nella ierogamia cosmica; i Denari, infine,
rappresentano l’immagine del mondo. Alle dieci Sefirot vengono di nuovo
associati le prime dieci lame o carte dei Tarocchi. A Keter corrispondono dunque
i quattro assi, e per estensione ciò significa che “la Corona di Dio porta
quattro fiori”; a Chokhmah, i quattro due, “la sua saggezza si espande e
forma quattro fiumi”. Con Binah, i quattro tre, “dà quattro prove della
sua intelligenza”; con Chesed, i quattro quattro “Egli è quattro opere
buone di misericordia”. Con Geburah, i quattro cinque “il suo rigore
punisce quattro volte cinque delitti”; con Tiferet, i quattro sei “la sua
beltà si rivela per i quattro puri raggi”. Con Netsah, i quattro sette “celebriamo
quattro volte la sua eterna vittoria”; con Hod, i quattro otto “quattro
volte trionfa nella sua eternità”; con Jesod, i quattro nove “il suo
trono si sostiene su quattro fondamenta”. Infine, con Malkut, i quattro
dieci “il suo unico regno è quattro volte uguale” . Éliphas Lévi a questo
punto si è costruito tre sistemi ermeneutici per la decifrazione dei Tarocchi;
dispone quindi di una discreta varietà di chiavi letture per affrontare
l’interpretazione di ogni lama. E così qualunque combinazione scaturirà dal
lancio delle carte, la lettura del disegno del Fato è assicurata: il cinque di
bastoni significa rigorosamente Geburah di Jod, cioè giustizia del Creatore o
collera dell’uomo; il sette di coppe significa vittoria della misericordia o
trionfo della donna; l’otto di spada significa conflitto o equilibrio
eterno. Naturalmente questa è solo l’interpretazione personale di Éliphas Lévi
sui Tarocchi, che differisce sensibilmente da quella di altri interpreti come ad
esempio Wirth o Jung. Tuttavia si tratta in fondo solo della conferma che nella
storia del pensiero esoterico - come per
qualunque altro campo della cultura - s’incontrano solo interpretazioni che
mettono fuori gioco la possibilità di arrivare ad una verità “in sé”. Quella che
Hegel definiva ironicamente come “filastrocca delle opinioni” non risparmia
nemmeno i lasciti degli esoteristi e degli occultisti.
Secondo Éliphas Lévi per dominare la luce astrale, il grande
agente magico, è necessario riuscire ad eseguire perfettamente due azioni
alchemiche fondamentali: il solve ed il coagula, l’atto del concentrare e quello
del proiettare, il fissare ed il muovere. In virtù delle corrispondenze
tra macro e microcosmo, l’adepto deve riuscire a realizzare prima in sé stesso
le due operazioni; e così, il coagula si ottiene con l’isolamento, ed il solve
con l’uso della catena magica. L’isolamento riesce a garantire la giusta
concentrazione e il corretto ripiegamento ascetico dell’anima liberata dalla
schiavitù delle passioni. Il possesso del proprio corpo astrale è
indispensabile, secondo Lévi, all’adepto che vuole dedicarsi alla Grande Opera.
Un ascetismo quasi di tipo indiano è prescritto da Lévi agli operatori della
magia: “morte delle gioie
della terra e dei piaceri della vita mortale”. E’ peraltro curioso che Lévi
attribuisca alla magia questa dimensione spirituale ed ascetica; ma è chiaro che
il termine è qui impiegato in un senso molto esteso, tendente a racchiudere
dottrine e correnti, che al contrario, non collimano con l’idea generale sulla
magia, così com’è stata desunta dalla storia delle religioni. La magia, contiene
in sé stessa la cifra di un atto coercitivo verso una potenza che si vuole
obbligare ad ubbidire e a piegarsi ad interessi privati o collettivi; a
vantaggio o a danno di singoli o di una comunità. Se la condizione essenziale
del mago diventa l’assenza di desiderio, allora è chiaro che per magia, Lévi,
intende tutt’altro: forse, addirittura, identificando con questo termine lo
stesso percorso iniziatico. Rimane il fatto che, ancora una volta, Éliphas Lévi
utilizza i termini senza specificare o circoscrivere il loro significato.
Qualunque sia, tuttavia, il senso che Lévi utilizza qui per
l’espressione “magia”, la rinuncia coagula è la condizione indispensabile
alla formazione della catena magica solve. Grazie alle correnti
magnetiche generate dall’azione di un gruppo è possibile proiettare la luce
astrale nella direzione voluta. La catena magica utilizza gli individui
suggestionabili, o predisposti all’isteria come veicoli della forza magnetica,
in grado di orientare la luce astrale. Éliphas Lévi spiega anche la
fenomenologia del genio - argomento che molto ha affascinato l’estetica
ottocentesca - in base al successo dell’uomo “eccentrico” nel forzare e vincere
le vecchie correnti magnetiche. Il genio, secondo Lévi, riesce a spezzare le
catene magiche del passato e a formarsene di proprie. Per Lévi dominare le
correnti magnetiche significa padroneggiare il movimento della luce astrale.
Un’altra buona regola, sempre per Lévi, consiste nell’aspettare il momento
giusto del deflusso della corrente, quando si vuole opporsi alla stessa. La
corrente è allora come un’onda che ha un massimo picco, ma poi inizia a
discendere nell’intensità: pretendere di contrastarla nella prima fase significa
andare incontro ad un sicuro smacco. Ora, secondo Lévi, basterebbe mettere
assieme un gruppo di persone facilmente suggestionabili, sollecitarle
adeguatamente, e questo basterebbe a creare una corrente magnetica. Del resto,
lo stesso autore più volte richiama la legge magica, che vuole il visibile
proporzionalmente commisurato all’invisibile. Perciò, se una catena magica
formata da persone istintivamente crede in qualcosa, si forma una corrente
magnetica che genera un riflesso della cosa creduta nella luce astrale: nasce
così la superstizione. Ma non è tutto. Secondo Éliphas Lévi, esiste un grande
agente magnetico universale che va continuamente alla ricerca di nuove catene
d’entusiasmo per generare nuove correnti. Come una forza latente o primordiale,
questo grande agente vuole riprodursi incessantemente in nuove direzioni
contingenti - secondo modalità che ricordanocuriosamente il Wille
schopenhaueriano, la volontà cieca, inconscia, e senza finalità de Il mondo
come volontà e rappresentazione -. Éliphas Lévi identifica la Grande Opera
con il possesso pieno dell’agente magico universale. Adesso lo stesso agente
magico viene equiparato dall’autore alla “materia prima”. Il potere di questa è,
in fondo, quello che permette l’esperienza della trasmutazione, da sempre
iscritta nel reticolo delle corrispondenze universali. Secondo la Tavola
Smeraldina, gli elementi inferiori sono equiparabili a quelli superiori, e
viceversa; lo stesso ermetismo neo-alessandrino propugna per delle vedute non
gerarchiche, in cui il divino sembra dimorare nei più umili strati della
materia, come un seme della terra, e così via. Con il sale filosofico, il
mercurio, e lo zolfo è quindi possibile operare la trasmutazione del substrato
materiale nell’oro spirituale. La stessa parola Arte, per Lévi, contiene
quest’idea in sé stessa - dal termine francese originale “art”, la lettera
A designa l’adattamento, la R rimanda alla realizzazione, e la T sta per
ternario-. L’adepto deve quindi realizzare la trasformazione dapprima in sé
stesso. Il simbolo di questa trasfigurazione alchemica è il pentagramma, ma
anche la lama dell’Impiccato. Soltanto apparentemente questa carta dei Tarocchi
raffigura l’impotenza totale: le braccia e le gambe dell’Impiccato disegnano una
croce sopra un triangolo, il segno alchemico del compimento della Grande Opera.
Ma anche il rovesciamento dei piedi al cielo, rimanda, sempre per l’autore, alla
spiritualizzazione. Secondo un’analogia simbolica che richiama l’albero
rovesciato delle Upanisad. Ma lo stesso Platone aveva suggerito l’immagine
dell’uomo come un tronco rovesciato, le cui radici si stendono in cielo ed i
rami in terra. L’idea della spiritualità umana raffigurata come un albero
rovesciato è presente anche nello Zohar : “l’Albero della Vita si estende
dall’alto al basso e il sole lo illumina interamente”.
Se nella luce astrale sono conservati i riflessi delle
persone e delle cose, a maggior ragione la stessa deve conservare le immagini
dei morti. Quando l’uomo muore, sempre secondo Lévi, esiste il rischio che il
corpo siderale non si dissolva; eventualità del resto abbastanza probabile,
quando non si è vissuto secondo i dettami della virtù. L’individuo quindi
possiede un corpo fisico ed uno siderale, insieme allo spirito. Al momento
della morte, quest’ultimo sempre e comunque si libra in cielo, ma il
rischio è che il cadavere astrale rimanga prigioniero delle passioni coltivate
in vita e non si dissolva nel nulla; concezione questa che rimanda abbastanza
nettamente al Fedro di Platone. Tramite la necromanzia è possibile evocare
queste immagini e costringerle a manifestarsi. Questi cadaveri astrali
tormentano i sogni delle fanciulle e vegliano sui tesori nascosti, secondo
l’inclinazione al vizio alimentata durante la vita terrena. La necromanzia può
quindi esorcizzare queste entità, a patto che l’operatore riesca ad abbandonare
lo stato di veglia e ad operare in una sorta di trance, di sonnambulismo lucido
in grado di scartare i riflessi e arrivare alla visione diretta dei raggi. In un
passaggio successivo, Éliphas Lévi evidenzia come nelle sedute spirituali sia
improbabile che gli spiriti si abbassino a comunicare con i mortali;
l’evocazione avviene solo per i ricordi che i medesimi spiriti hanno lasciato
nella luce astrale: il corpo siderale stesso deve, infatti, essere inteso
proprio come un “ricordo” che l’anima del defunto abbandona sulla terra al
momento del trapasso. Esso può essere considerato come intermediario tra l’anima
e il corpo materiale: da qui i viaggi del corpo siderale, durante lo stato di
sonno. Ma secondo Lévi, il corpo siderale prende la forma stessa dei pensieri
del soggetto; perciò se quest’ultimo ha la forma di un lupo mannaro, lo si deve
alle compulsioni selvagge e sanguinarie che abitano il sognatore. È evidente la
prossimità di questa concezione con le moderne teorie psicoanalitiche,
specialmente con quelle di Freud, dove il sogno altro non è che il “ritorno del
perturbante” sotto forma di travestimento simbolico. Ma a differenza della
psicoanalisi, il perturbante di Lévi non si limita alla trasposizione simbolica,
ma si anima concretamente per iniziare a vagare nei campi e spaventare i
passanti. Naturalmente la manifestazione trasfigurata del corpo siderale è
vulnerabile - ed in virtù della legge delle corrispondenze - le ferite inferte
saranno presenti sul corpo materiale al momento del risveglio. Con questo
pervertimento della luce astrale, Lévi spiega anche il fenomeno delle ossessioni
diaboliche. Si tratta di una malattia dell’apparecchio nervoso, che assorbe o
proietta in eccesso la luce astrale pervertita. Un disturbo della volontà
causato dall’ipertensione. Tra le persone si verifica dunque, sempre per Lévi,
uno scambio di correnti magnetiche, generato dalle leggi dell’attrazione e della
repulsione. I corpi siderali, il potere dell’immaginazione: l’uomo comune è
destinato ad essere influenzato e ad influenzare a sua volta gli individui
predisposti ad inter-reagire con la sua individualità. Soltanto l’adepto
possiede le difese necessarie contro il magnetismo, perché soltanto lui è in
grado di padroneggiare il potere della luce astrale. La magia nera, sempre per
Lévi, non è altro che l’uso di questa forza per perseguire il male. La capacità
di evocare le forme della luce astrale, quando è diretta dalla follia e dalla
malvagità, inevitabilmente produce figure mostruose e diaboliche: “in magia
nera, il Diavolo è il grande agente magico impiegato per il male da una volontà
perversa”. Il potere magico quindi è in sé neutrale, il colore (nera, bianca,
ecc.) dipende dalle finalità perseguite dall’operatore. Ciò nondimeno per
esercitare un sortilegio con una certa efficacia è indispensabile coltivare un
odio puro e alieno dal lucro personale. Secondo Lévi la gelosia, la cupidigia e
la passione sessuale possono, in quanto forze di attrazione, annullare il potere
di proiezione del sortilegio, fino a farlo ricadere sull’operatore. La magia
cerimoniale, in questo senso, serve a rafforzare e a fissare la volontà di chi
si accinge ad effettuare un sortilegio. L’addestramento della volontà è un
passaggio indispensabile all’ottenimento del potere sulla luce astrale. Una
volontà molto determinata e scevra da passioni inferiori, è, in ogni caso,
destinata a raggiungere i suoi fini malefici. Tuttavia, anche i gesti inconsci
delle mani e degli occhi possono favorire l’involontaria proiezione delle
correnti magnetiche all’esterno. Ogni individuo è saturo di luce astrale, ed è
preferibile usare certe accortezze quando si dà la mano o si fissa un altro
negli occhi. Anche altre parti del corpo umano fungono da ricettacoli dei segni
impressi nella luce astrale: la fronte e la mano recano la lettera del destino
personale. Si ricorderà come la stessa Bestia dell’Apocalisse abbia iscritto il
numero nelle stesse parti del corpo. Tutto si riflette, secondo Lévi, nella luce
astrale; anche gli astri, che a loro volta incidono il fato individuale nelle
fronti e nelle mani. La divinazione è quindi, secondo Éliphas Lévi, l’arte di
saper leggere questi segni. Una sola lettera del destino s’iscrive nella fronte
dell’uomo, destinata a dominare interamente il suo accadere. Qualora questa
lettera risulti mal conformata, è presumibile prevedere la presenza di una forte
conflittualità tra la volontà del singolo e la particolarità del fato.
Nella parte finale del suo Dogma, Éliphas Lévi si sofferma
sul concorso fraterno tra la ragione e la fede, equiparate alle colonne del
tempio, Jakin e Bohas. Ma tutto il reale è per Lévi segnato dalla dicotomia
essenziale: sole/luna, destra/sinistra, maschile/femminile, ecc. La dualità,
tuttavia, s’iscrive nel reticolo delle corrispondenze analogiche; perciò,
secondo l’assunto della Tavola Smeraldina, anche l’essere più umile è uno
specchio di Dio. Perfino il verme della terra è un riflesso dell’immagine
divina. Si tratta del principio d’interdipendenza universale che riguarda i
rapporti tra macro e microcosmo, ma anche i contrari: relazioni occulte, tra
metalli, pianeti, piante, ecc. Secondo Lévi, l’analogia tra i contrari è
possibile, proprio perché la dualità discende dall’identica radice, ossia
dall’Uno. Parlando del significato segreto della parola francese “devin” -
indovino - l’autore sostiene che si deve “fare rientrare il cinque nel
quattro, il quattro nel tre, (il) tre nel due e (il) due in Uno, traducendo
quest’UNO in lettere dall’alfabeto ebraico primitivo, (l’operatore N.d.R.)
scriverà il nome occulto del Grande Arcano e possederà una parola della quale il
sacro tetragramma stesso non è che pallida immagine”. Tutto deriva dall’Uno,
ma proprio per questo è annullata qualsiasi assiologia che tenda a definire una
priorità tra l’altro ed il basso, come ricorda la Tavola Smeraldina. Siamo
quindi in presenza di una concezione che potremmo definire, con qualche riserva,
panteistica. Principalmente, perché Lévi mantiene la differenza essenziale tra i
riflessi della luce astrale e la visione diretta. Tuttavia, l’iniziato, una
volta riconosciuta l’illusione sottesa al divenire, deve essere in grado di
liberarsene e riconoscere la discendenza del tutto dall’Uno. Inoltre, la
gerarchia è mantenuta da Lévi nella contrapposizione tra il mondo profano e gli
iniziati in possesso della conoscenza sull’arcano.
L’armonia, secondo Lévi, non è altro che l’equilibrio
presente nell’analogia dei contrari: tuttavia la causa ultima di tutte le cose è
l’unità assoluta, l’Uno-tutto. Dall’unità deriva il tutto, che ad essa ritorna:
“l’analogia è il solo possibile mediatore fra il visibile e l’invisibile, fra il
finito e l’infinito”. Appare quindi chiaro che il valore ontologico
dell’analogia è dichiarato, solo per ricondurre immediatamente la dicotomica
struttura del reale alla rassicurante filiazione dall’Uno. La contraddizione
fenomenica è quindi disciolta nel reticolo delle corrispondenze analogiche, in
vista dell’emanazione dall’unico Principio. In altre parole, Lévi produce un
alleggerimento della dicotomia intrinseca al divenire, evidenziando che la
contraddizione è solo apparente all’interno della tautologia fondamentale; se
secondo l’assunto della Tavola Smeraldina, “ciò che è in alto” equivale
analogicamente a “ciò che è in basso”, il caos e la contraddizione non esistono,
in quanto i due contrari si equiparano nella loro identità reciproca e in quella
della causa prima da cui derivano. I contrapposti sono identici, perché a loro
volta sono riconducibili al Principio che li ha emanati. Il pensiero di fondo di
Lévi è quindi monista: ma strutturato in un progetto - quello del Dogma - in cui
si propone di conciliare il Cristianesimo con la Cabbala ed i Tarocchi. Non a
caso il Dogma si chiude con il richiamo alla lama che simboleggia il più alto
potere iniziatico, a detta di Lévi: il Mondo, simbolo della totalità del mondo e
dell’uomo, e - secondo Gilbert Durand - dell’antagonismo equilibrato.
La Chiave dei Grandi Misteri si apre con l’elenco di una
serie di problemi classici di natura teologica, che Éliphas Lévi cerca di
risolvere. Sono questioni concernenti l’esistenza di Dio, della vera
religione e dei suoi misteri, del confine tra fede e superstizione, del modo di
volgere a favore le obiezioni della filosofia. In altre parole, si tratta di
argomenti apologetici. Éliphas Lévi, però, sposa una prospettiva pseudo-deista,
piuttosto che fideista, in quanto definisce la religione “naturale” come una
facoltà dell’anima umana, assimilabile all’intelligenza ed all’amore. Il passo
indietro rispetto al deismo classico, Lévi lo compie quando ricorda che la vera
religione naturale è quella rivelata; mentre il movimento deista del XVII e
XVIII secolo, si rifiutava di prendere in considerazione tutto quello che
esulava la ragione naturale, rifiutando in modo particolare il ricorso a
qualsiasi tipo di rivelazione. La questione centrale è che Lévi si sforza di
trovare un punto d’incontro tra la fede e la ragione scientifica, preoccupandosi
di dimostrare come i rispettivi oggetti d’indagine siano differenti, e perciò
ognuna non invade il territorio dell’altra. La scienza indaga il cognito, la
fede l’incognito: entrambe sono indispensabili all’intelligenza umana. Tuttavia,
non si tratta di un rapporto paritetico, perché nel sodalizio, è la ragione ad
essere subordinata alla fede. Solo quest’ultima è in grado di raggiungere Dio,
mentre la scienza non può assolutamente pronunciarsi sulla Sua esistenza.
Nell’insegnamento della Cabbala, Dio è l’Uno da cui emanano i numeri. Lévi
illustra quindi la numerosofia sottesa ai dogmi della religione primordiale.
L’Unità simboleggia il principio ed il Tutto, la verità panteistica
dell’Uomo-Dio, Il Binario, il principio femminile, il Ternario il
numero della creazione - attraverso l’autoriproduzione del principio divino, ma
anche mediante le polarità contrapposte -. Il Quaternario è il numero
della forza, riprendendo le considerazioni già espresse nel Dogma: “è il
ternario completato dal suo prodotto, è l’unità ribelle riconciliata alla
trinità sovrana” . Lévi, in definitiva aggiunge arbitrariamente un passaggio in
più al normale movimento triadico della dialettica hegeliana, in cui è il terzo
termine a sigillare e concludere l’Aufhebung. La tesi e l’antitesi si superano
conservandosi nella sintesi, ma i passaggi sono tre: non si capisce perché mai,
se il ternario è già un tutto dovrebbe essere completato dal suo prodotto. Due
sono le possibilità, 1) o la trinità non è veramente sovrana, e quindi ha una
ragione di essere il quaternario ( 1+2+3=4); 2) oppure, al contrario, essa è
effettivamente sovrana, ma allora la completezza è già data dalla triade, senza
bisogno di aggiunte addizionali (1+2 = 3). Non è nemmeno possibile
interpretare il passaggio come allegoria soteriologica dell’uomo versò la
trinità cristiana, perché non si spiegherebbe l’inutile reiterazione dell’uomo
come secondo termine il Figlio e come quarto l'homo religiosus. Il
Figlio, divina incarnazione, conterrebbe già l’Uomo, quindi. Questa sorta di
“cattiva infinità” già emersa nell’interpretazione del quaternario, riaffiora
anche per il quinario, di cui Lévi dà un’interpretazione abbastanza
sorprendente, identificandolo con il numero religioso per eccellenza, in quanto
riunione di quello di Dio con quello della donna (3+2). Anche in questo caso,
non viene motivata la ragione di questa reiterazione; non solo il ternario -
secondo quanto scritto da Lévi, numero della creazione - avrebbe dovuto
essere già comprensivo ontologicamente del Tutto, ma addirittura la possibilità
di un’integrazione addizionale dell’unità con l’insieme era già stata
contemplata nel quaternario. A meno che non si voglia considerare il quaternario
come esclusivo numero del ricongiungimento riservato al polo maschile, e il
quinario a quello femminile. Poteva, però, essere sufficiente il ternario, senza
bisogno di ulteriori frammentazioni. Il senario è, sempre per l’autore francese,
il numero della prova iniziatica, mentre il settenario è il numero biblico.
L’otto è il numero dell’equilibrio tra i contrapposti: una reazione segue sempre
a un’azione, l’Anticristo deve la sua esistenza a Cristo. Il nove è il simbolo
del percorso solitario dell’Eremita, il dieci il numero assoluto della
Cabbala. L’undici è il numero della forza, il dodici del simbolo
universale, il tredici della nascita e della morte. Il quattordici simboleggia
l’unità, il quindici, viceversa, la separazione. Il sedici raffigura il tempio,
il diciassette la stella dell’amore e dell’intelligenza. Il diciotto il dogma
velato, il diciannove - al contrario - la luce divina. Queste
primi diciannove numeri, secondo Lévi, costituiscono le chiavi della teologia
occulta, mentre i rimanenti sono le chiavi della natura. Con questa numerologia,
Lévi è convinto di aver risposto alla prima domanda sull’esistenza di Dio. Ad
una prima impressione, il risultato potrebbe sembrare alquanto insoddisfacente,
tuttavia è inutile pretendere da Éliphas Lévi una risposta puntuale e minuziosa,
quale potrebbe essere quella di un teologo o di un filosofo. Egli è
essenzialmente un occultista, e inevitabilmente la sua risposta non può avere la
forza esaustiva dell’argomentazione: Lévi si limita a fare intravedere le
relazioni intrinseche tra i diciannove numeri, e a chiamare questi rapporti Dio.
Il primo, l’idea dell’alleanza tra l’uomo e Dio - Adam Kadmon -, rimanda
progressivamente all’ultimo, al diciannove, simbolo della luce, passando
progressivamente attraverso gli altri diciassette numeri. Questo Tutto numerico,
questa concatenazione necessaria, è Dio, e Lévi ritiene di non dover aggiungere
altro.
Nell’affrontare il secondo problema - la questione della
plausibilità di una vera religione - Éliphas Lévi dopo la paradossale
identificazione tra ragione naturale e Rivelazione, ravvisa nel sentimento della
carità, la cifra distintiva dell’autentica fede universale. La carità permette
anche di superare il terzo problema e di realizzare l’accordo tra la ragione e
la fede, conquistando l’intelligenza dei misteri. Tuttavia, più che di accordo
si potrebbe parlare piuttosto di un patto di non aggressione unilaterale: la
scienza deve rinunciare a spiegare il dogma, dal momento che se tentasse di
dimostrarlo matematicamente, finirebbe per svilirlo. Con la quarta soluzione, è
ribadito quindi il primato della fede sulla ragione. La separazione della vera
religione dalla superstizione - puro formalismo svuotato di significato - e dal
fanatismo - feticismo iconografico - è la risposta al quinto problema.
Nella terza parte de La Chiave dei Grandi Misteri,
Éliphas Lévi affronta la natura del grande agente magico, che aveva già trattato
sinteticamente in Il Dogma dell’Alta Magia, prevalentemente a proposito della
luce astrale. Nella Chiave, viene delineata l’essenza di quest’unica sostanza
diffusa nell’infinito, in cielo come in terra, sottile e fissa. Si tratta della
stessa sostanza ribattezzata da Ermete il Gran Telesma, che può manifestarsi
come luce, ma anche come vibrazione perenne, messa in moto dalle forze
magnetiche. Questo fluido onnicomprensivo, questo agente magico, appare con
modalità cangianti quando attraversa i differenti stati e le pluralità degli
enti: nell’infinito coincide con l’etere, negli astri con la luce astrale, negli
esseri inferiori si manifesta come fluido magnetico, nell’uomo come corpo
astrale o mediatore plastico. Si ripresenta il solito spostamento semantico dei
termini, in cui Lévi sovente incappa: nel Dogma, come si ricorderà, il grande
agente magico era identificato con la luce astrale, mentre nella Chiave
quest’ultima assume solamente il valore di un’applicazione particolare e non
coincide per nulla con il fluido primordiale. Éliphas Lévi chiama dunque con la
stessa espressione “luce astrale” sia il concetto generale che la determinazione
specifica, ma è evidente che per lui questo non rappresenta una vera difficoltà,
dal momento che ciò di cui si tratta è unicamente il grande agente magico,
indipendentemente da come si decida di chiamarlo. È sempre lo stesso fluido, che
come uno specchio riflette i pensieri e le percezioni di ogni creatura vivente e
di tutte le entità sovrannaturali. Questo medium conserva e trattiene tutto, “le
immagini di ciò che è stato, i riflessi dei mondi passati e, per analogia, gli
abbozzi dei mondi futuri”; potremmo oggi ribattezzarlo “Immaginario”,
richiamandoci a Gilbert Durand, perché è come una sorta di serbatoio universale
su cui tutto s’imprime perennemente come traccia ipostatica, mentre l’essenza
del pensato scivola via nel tempo. Rimangono perciò soltanto le forme spettrali,
i riflessi, di quest’energia primitiva che altro non è che il vissuto con le sue
emozioni, desideri, volizioni: le determinazioni dell’agire si esauriscono
concretandosi in risultati o fallimenti, o viceversa finiscono per riprodurre a
loro volta altre emozioni-reazioni. Questa sostanza elementare, questo fluido
universale in cui si specchiano i riflessi di tutto ciò che è accaduto, potrebbe
accadere o accadrà, è determinato dal perfetto equilibrio del moto e della
stasi, ma è al contempo fisso o volatile: “il fisso attira il volatile per
fissarlo, mentre il volatile rode il fisso per volatizzarlo” Il fluido è
transeunte, la stasi occasionale deriva dall’equilibrio delle forze magnetiche
contrapposte che si annullano a vicenda. La mancanza di equilibrio rimette in
moto il fluido, mentre se esso è controbilanciato da centri magnetici che si
azzerano vicendevolmente agendo sul suo divenire, si genera inevitabilmente la
stasi. Il mediatore plastico dell’uomo può - in seguito ad un lungo ed indefesso
addestramento - agire come una calamita che attira o respinge questo fluido
universale che qui Lévi ritorna a chiamare “luce astrale”, registrando
l’ennesimo spostamento semantico. Ma questo mediatore plastico è attivato dalla
forza dell’immaginazione. Come il corpo si nutre dei prodotti della terra,
il corpo astrale, o mediatore plastico, si ciba di luce astrale, assorbendola
durante la veglia con la respirazione ritmata e nello stato di sonno.
Mentre si dorme, secondo Lévi, ci s’immerge in un oceano di luce astrale, “in
cui galleggiano innumerevoli immagini, resti di esistenze naufragate, miraggi e
riflessi di quelle che passano, presentimenti di quelli che nascono”. Se si
produce un sovraccarico di luce astrale nel mediatore plastico, il sonnambulismo
naturale provvede con il moto inconscio del corpo a scaricare l'energia in
eccesso. Se il mediatore plastico viene danneggiato o subisce lesioni, si
producono degli stati allucinatori nel soggetto. È molto facile, inoltre, che
mediatori plastici di individui diversi si respingano o si attraggano, secondo
modalità analoghe a quelle dei campi elettrici, producendo così reazioni innate
di simpatia e antipatia. Da qui la necessità di controllare le passioni; è
evidente che i mediatori plastici possono assorbire solo una parte delle
suggestioni fluidiche, così che quello che non si riesce a rimuovere con il
sonnambulismo, è destinato a tramutarsi nel suo opposto: la passione in
ossessione, l’odio in amore, ecc.. secondo l’autore, le nature passionali sono
come delle calamite esaltate, da cui occorre guardarsi. Si può magnetizzare
direttamente il mediatore plastico di un’altra persona, o agire indirettamente
sulla sua volontà, lasciando che questa a sua volta influenzi il corpo astrale.
Il contatto fisico, ma anche lo sguardo e la voce provocano la magnetizzazione
dell’oggetto. È evidente il credito di Éliphas Lévi verso Mesmer e le sue teorie
sul magnetismo animale. Mesmer riteneva che il fluido magnetico risiedesse
nell’uomo come negli animali, e che potesse essere trasmesso mediante
particolari gesti delle mani, denominati “passi magnetici”. La magnetizzazione,
secondo Mesmer, provocava nel paziente uno stato di sonnambulismo indotto, fino
a teorizzare la necessità dell’edificazione di una vera e propria “educazione
sonnambolica”. Da qui a postulare che il sonnambulismo sia dovuto all’eccessiva
accumulazione magnetica di luce astrale, come pensa Lévi, il passo è breve.
Anche l’importanza che l’occultista francese attribuisce ai sogni, come
rivelatori dello stato di salute del mediatore plastico, è mutuata
dall’intuizione pre-freudiana di Mesmer sull’esistenza dell’inconscio.
Ricapitolando abbiamo visto che per Lévi le allucinazioni
sono prodotte da lesioni al mediatore plastico, mentre il sonnambulismo è
generato da moti irregolari della luce astrale assorbita in eccesso. Il
mediatore plastico - o corpo astrale - aspira e respira la luce astrale, come il
corpo fisico fa con l’aria. È evidente che siamo in presenza di un’unica
sostanza o fluido che si determina peculiarmente all’esterno - luce astrale - ed
all’interno dell’uomo - corpo astrale - senza per questo mutare natura. Si
tratta sempre della stesso fluido universale in applicazioni differenziate: ecco
perché il mediatore plastico - fatto ad immagine e somiglianza del corpo fisico
- assorbe la luce astrale, anche se non possiede una “capienza” illimitata. Non
può averla, perché essendo una copia fedele del corpo grossolano, riproduce
l’estensione fisica del suo principium individuationis nello spazio. È una
sostanza universale che sì è venuta a delimitare nel finito e nel contingente,
così come l’acqua prende la forma del recipiente. Quindi, dal momento che il
mediatore plastico non ha capacità illimitate, diventa essenziale regolarne le
potenzialità ed evitare la sovraesposizione cogente. Possedere il potere
d’intervenire sulla luce astrale tramite l’immaginazione opportunamente
addestrata, significa impossessarsi della forza magnetica: per Lévi la Cabbala -
assimilata adesso all’Alta Magia - è la scienza della luce. La Cabbala stessa
costituisce il sostrato della vera religione, conquistabile qualora si sollevi
il velo trasparente che appanna le verità eterne del Giudaismo e del
Cristianesimo. Tuttavia l’eccessiva enfasi posta da alcuni cabbalisti sulla
legge delle analogie universali, ha finito per declassare questa scienza
riducendola a pratiche evocative, di scongiuri ed incantesimi, fino a sconfinare
pericolosamente nella magia nera. La legge delle corrispondenze analogiche tra
segni e cose, ha prodotto in alcuni adepti un interesse esclusivo sulla forza
evocativa delle parole: pronunciare il nome di Dio, equivale quindi a
manifestare la Sua potenza. Pronunciare il nome di un essere, significa
evocarlo, o addirittura forgiarlo dal nulla. Allo stesso tempo, essendo il
pensiero assimilabile ad una sorta di linguaggio silenzioso e interiorizzato, è
evidente che i pensieri degli operatori vanno ad incidersi nella luce astrale.
Per Lévi, diventa quindi indispensabile che l’adepto acquisisca una sorta
d’educazione del linguaggio e di morigeratezza del pensiero, evitando di
profferire parole vane o di formulare astrazioni disarmoniche. In particolare, è
il potere dell’immaginazione che attira la luce astrale e la modella secondo i
desideri dell’operatore: i sogni e i pensieri ricevono una forma nella luce
astrale. Con questa luce dunque si conservano e si riproducono le effigi del
desiderio, guidate dalle vibrazioni dell’immaginazione creatrice. Si ricorderà
che nel Dogma dell’Alta Magia, Éliphas Lévi aveva indicato chiaramente che si
tratta di forme alterate delle idee originali, impresse come riflessi sulla luce
astrale: la sua formazione platonica gli nega la possibilità di conoscere le
forme originali già nel regno del divenire. Tuttavia, data la corrispondenza
analogica macro/microcosmo, agire sulla copia significa riuscire ad operare sul
modello originario. Ma è possibile agire indisturbati anche sulle altrui
volontà. Per Éliphas Lévi vi sono due modalità di esistenza proprie a tutti gli
esseri, quella individuale e quella collettiva. Si accede a quest’ultima
mediante il sonno e l’estasi. È possibile quindi agire sul corpo siderale della
vittima, quando questa sta dormendo, a patto di riuscire a padroneggiare con la
forza dell’immaginazione il doppio movimento d’attrazione e repulsione della
luce astrale. I corpi materiali si attirano e respingono in ogni caso durante lo
stato di veglia: per riuscire ad invertire le correnti magnetiche del corpo
siderale della vittima è necessario influenzarlo durante il sonno. Nel momento
della regressione della coscienza nell’oceano indistinto dell’attività onirica,
la vittima è molto vulnerabile e suggestionabile. Ma si può ottenere lo stesso
risultato, in tutti quegli stati di diminuita attività della coscienza, quando
le difese della mente sono temporaneamente abbassate. È per questo motivo che la
vicinanza della gente inferma provoca spesso dei brutti sogni, è per la stessa
ragione che avvengono quegli strani casi di suggestione nociva nelle donne
incinte, e si producono strane malattie psicosomatiche a contatto di individui
malati o malvagi. Per Éliphas Lévi, siamo tutti esposti al rischio d’influenze
magnetiche: “la luce magnetica divora incessantemente, perché crea sempre e
perché, per produrre continuamente, bisogna eternamente assorbire”. Si ricorderà
a tal proposito, quanto era stato scritto dall’autore nel breve saggio sulla
Magia delle Campagne, circa le strane allucinazioni dei pastori. L’unica
differenza risiede in chi subisce passivamente le correnti magnetiche della luce
astrale ed in chi riesce a dirigerla tramite il potere dell’immaginazione
creatrice, proiettandone e riproducendone a volontà, riflessi ed immagini. La
stessa perdita di controllo del mediatore plastico, provocata dall’eccessivo
assorbimento della luce astrale, genera degli spettri, o per meglio dire,
dei fantasmi fluidici. Éliphas Lévi prende quindi le distanze dalla cultura
spiritista dell’epoca, formatasi sulle originali teorie di Kardec: i fantasmi
che infestano le abitazioni, non sono spiriti di morti, ma coagulazioni
fluidiche che possono essere dissolte. È allora evidente, alla luce di
tutte queste osservazioni, che Éliphas Lévi attribuisce un’importanza
fondamentale al controllo della luce astrale e del mediatore plastico, poiché se
al di fuori dell’uomo non esistono entità demoniache o angeliche che possano
concretamente limitare il suo dominio, padroneggiare sé stessi equivale ad
assicurarsi un potere immenso su tutto il macrocosmo. Diventa essenziale allora,
per Lévi, nel Libro Secondo della Chiave, dedicarsi all’elaborazione di
una teoria della volontà. L’autore francese si cimenta qui, con un
problema filosofico classico, cercando di conciliare la possibilità della
libertà umana con l’idea dell’onnipotenza di Dio. Secondo Sartre, il dilemma era
irriducibile, e si doveva pertanto arrivare a compiere una scelta radicale in
favore dell’Uno o dell’altra. Éliphas Lévi propende per una soluzione che
mi ricorda molto la mistica musulmana, piuttosto che sant’Agostino e i Dottori
della Chiesa. In questa prospettiva, l’autentica libertà umana non può che
coincidere con la volontà di Dio, perché quando l’uomo si libera dalle cattive
passioni e squarcia il velo dell’ignoranza sensuale, deve necessariamente
desiderare le stesse cose che vuole Dio. Alla vera libertà si arriva dunque alla
fine di un lungo cammino interiore: una volta presa coscienza della sua natura
divina, l’uomo si libera dalla dispersione compulsiva indotta dalle suggestioni
caduche del mondo del divenire, per acquistare platonicamente coscienza del
regno delle essenze. La libertà, dunque, per Lévi, consegue ad un lungo
perfezionamento interiore, e non coincide con la possibilità “umana,
troppo, umana” di fare le proprie scelte, anche se sbagliate e profane. In altre
parole, nella prospettiva iniziatica di Lévi, non è contemplata la possibilità
di scegliere la caducità ed il mondo del divenire. Ma se definiamo la libertà
come una sostanziale “assenza di costrizione”, allora la soluzione caldeggiata
da Lévi è fallita.
Ritornando alla teoria della volontà, si deve ricordare che
la forza si concreta principalmente nella parola. Da buon cabbalista, Éliphas
Lévi sa perfettamente che “ tutta la magia è in una parola, e questa parola
pronunciata cabalisticamente, è più forte di tutte le potenze del cielo, della
terra e dell’inferno” . Éliphas Lévi identifica la parola magica con due
vocaboli “ Adonai”, “Agla” e con un’espressione “Jod he vau he”, salvo poi
ricordare che senza aver conseguito l’affinamento superumano e magico della
volontà, i risultati agognati sono destinati allo smacco ed all’insuccesso. Si
tratta dunque, di volere “con tutto il cuore, al punto di spezzare per lei i
propri aspetti più cari; con tutte le proprie forze, al punto d’esporre la
propria salute, la propria fortuna, la propria vita”.
Naturalmente per Lévi il miglioramento spirituale del singolo
contribuisce alla crescita morale collettiva. È per questo che gli uomini
intelligenti e buoni rischiarano e migliorano il loro ambiente familiare e
sociale, mentre gli stupidi e malvagi riflettono solo negatività e basse
compulsioni. La vera iattura è che i sentimenti di simpatia o antipatia, e più
in generale le affezioni, sono influenzate dalle correnti magnetiche e perciò
non possono essere controllate dall’uomo comune. I fluidi della luce astrale
possono attrarre inconsciamente verso individui, al contrario da evitare.
L’iniziato è al riparo da questi rischi perché conosce il punto d’equilibrio del
proprio mediatore plastico, denominato “Ascendente”, mentre il “Flagum” è il
riflesso delle idee individuali nella luce astrale. La conoscenza del proprio
Flagum permette di determinare l’Ascendente personale, indirizzandone la parte
attiva verso quella passiva di un altro che si vuole sottomettere.
Mentre gli individui che esercitano inconsapevolmente delle influenze astrali
nocive sugli altri, di solito vivono isolati dalla comunità civile o a stretto
contatto quotidiano con animali. Ritornando sugli argomenti già proposti nella
Magia delle Campagne e Stregoneria dei Pastori, Éliphas Lévi crede che
specialmente i pastori siano soggetti a scambi magnetici con il gregge, da cui
ricevono correnti fluidiche negative che sovente producono effetti somatici di
possessione diabolica; per converso anche gli animali subiscono il fluido
negativo del pastore, rischiando così di cadere vittime di misteriose malattie
che nel giro di brevissimo tempo conducono alla decimazione del gregge. Per
Lévi, i pastori sono i tipici esempi d’individui destinati a subire passivamente
i fluidi astrali e pertanto a non essere liberi, mentre solo pochissimi iniziati
sono in grado di dirigere le correnti magnetiche, guadagnandosi così la vera
indipendenza ed il controllo della vita. Si tratta infine di fare una scelta
etica - possibile ovviamente solo a chi è pervenuto a conoscere le leggi
magnetiche - tra la vita, intesa come autocontrollo ed esercizio della volontà
orientata verso il bene e la luce, e la morte, ossia la schiavitù dell’esistenza
animalesca soggiogata alle correnti astrali. Ma per tutti quelli - e sono
ovviamente la maggioranza - che scelgono la dissoluzione abbandonandosi al
vortice delle suggestioni compulsive, è quasi sicura una fine tragica,
materializzata negli abissi dell’omicidio e del suicidio. Invece, al contrario,
coloro che hanno scelto di addestrare il proprio mediatore plastico al controllo
della luce astrale, sono immediatamente riconoscibili per l’armoniosa grazia che
emanano i loro corpi. Per Éliphas Lévi la fisiognomica individuale riflette,
innanzi tutto, i risultati dell’educazione “magnetica”: così la bellezza fisica
è destinata a sfiorire precocemente negli spiriti lussuriosi, mentre si conserva
levigando le proporzioni del corpo nei virtuosi. Secondo la legge delle
corrispondenze universali esemplificata mirabilmente dalla Tavola Smeraldina,
niente è dovuto al caso, l’interiore necessariamente si riflette sull’esteriore
e viceversa; non è possibile che un pensiero o un sentimento non si trasformi
immediatamente in un’energia capace di determinare una trasmutazione
dell’ambiente e del soggetto stesso. Si capisce quindi perché sia così
importante riuscire a dominare le forze astrali che da sempre abitano nel
mediatore plastico: “L’uomo che sa comandare a sé stesso è re di tutta la
natura”. Il mito di Circe, in fondo, non è che la trasposizione simbolica del
potere magnetico che un’ascendente esercita su di un altro contrapposto. La
fascinazione femminile di Circe tramuta in porci i compagni di Ulisse, perché
agisce sul loro ascendente sovraccarico di pathos sessuale; Éliphas Lévi, per
sfuggire alla forza delle suggestioni, suggerisce di visualizzare degli animali
che raffigurino simbolicamente le qualità necessarie ad ottenere una reazione
nervosa immediata: il domatore di leoni, ad esempio, dovrà convincersi di essere
lui stesso un leone che si trova di fronte a dei semplici cani. Il segreto, per
Lévi, è racchiuso tutto in questi rapporti di forza tra ascendenti: quando
s’incontrano due polarità contrapposte, inevitabilmente si crea un rapporto di
dominazione. Se la polarità è identica, come può esserlo tra due caratteri
simili, non accade niente, perché non si crea il flusso magnetico di base. Ma
nel caso che le polarità siano contrapposte- e quindi con caratteri
complementari - allora tra i due prevale chi ha raggiunto un migliore
addestramento magnetico. Ecco, quindi, spiegati i motivi dell’insistenza
dell’autore sulla morigeratezza delle passioni e sull’autocontrollo. Il più
forte magneticamente - quello con la volontà e l’immaginazione creatrice più
sviluppate - è destinato all’esercizio del comando. Si comprende ora, perché
Lévi più volte nelle sue opere riconduce l’alta magia alle leggi della morale
naturale. Nella prospettiva teorica dell’autore, la morale, educando
l’uomo alla rimozione delle pulsioni ed all’educazione sociale, preserva
l’adepto dalla dispersione energetica. La morale centralizza il potere
magnetico, mentre le pulsioni provocano un notevole dispendio fluidico,
costringendo il soggetto ad inseguire passioni effimere che svuotano le residue
forze accumulate nel mediatore plastico. Al di là della formazione cattolica
dell’autore - che sarebbe ingenuo pensare definitivamente rimossa - si
denota chiaramente in questa concezione che la morale, l’ethos, non è più guida
per l’esercizio virtuoso e disinteressato del bene, ma piuttosto uno strumento
per accumulare forza. Possiamo quindi scorgere tra le righe finali un parallelo
con le pagine nietzscheane della Genealogia della Morale, dove la morale non è
altro che l’interiorizzazione della volontà di potenza. Ed in effetti, Lévi non
è andato molto lontano dalle conclusioni del pensatore tedesco, se non fosse che
vi ha aggiunto le acquisizioni del mesmerismo e della nascente sottocultura
spiritistica dell’epoca. Per Éliphas Lévi, una volta squarciato il velo
dell’ignoranza, si tratta di scegliere tra la luce e l’immortalità e le tenebre
e l’ignoranza, tra Dio ed il Diavolo. L’uomo, ha in sé un grande potere che gli
deriva dalla conoscenza delle leggi magnetiche: il suo destino consegue dalla
decisione sull’uso che vorrà farne. Non a caso, Éliphas Lévi, arrivato alla fine
della Chiave, svela che il Grande Arcano, il segreto incomunicabile, è proprio
questa scienza assoluta del bene e del male.
Lo scopo primario dell’opera di Éliphas Lévi deve
probabilmente essere individuato nello sforzo incessante di accordare la
Cabbala e l’insegnamento dei Tarocchi alla dottrina cattolica, ma un rilievo
particolare assume, nei suoi libri, la teoria mesmerica continuamente ricondotta
all’interpretazione dinamica dei fenomeni della luce astrale. Nell’opera
di Lévi esiste una parte speculativa, alla quale è riservato il progetto
cabbalistico sopra indicato, ed una parte pratica che consiste nel controllo del
mediatore plastico e delle correnti magnetiche. L’occultismo moderno, così come
viene a configurarsi nell’età industriale, non può limitarsi ad essere una
corrente mistica meramente intimistica e quietista, ma deve al contrario operare
incessantemente nella ricerca empirica. L’occultismo ottocentesco radicandosi
nella stessa dimensione ottimistica ed utopica propria all’ideologia delle
macchine, aspira al padroneggiamento dell’esistente. Il progetto, nel quale
s’iscrive la corrente che si pone in continuità oggettiva con la philosophia
occulta medievale, è il controllo e l’eventuale rovesciamento del reale, sentito
come restrizione alle aspirazioni individuali e fonte di frustrazione per gli
aneliti dell’anima. Rispetto al magismo esotico delle culture non occidentali,
in cui lo scopo delle evocazioni e degli esorcismi può essere tanto individuale
che collettivo - volto al soddisfacimento di un bisogno individuale come alla
benedizione di un villaggio - l’occultista moderno non esce mai dalla dimensione
soggettiva. L’antropocentrismo magico dell’occultismo moderno è sempre
rigorosamente mirato al perfezionamento individuale. L’interesse collettivo è
realizzato solo in maniera riflessa, come estensione del potere psichico del
singolo al milieu e addirittura all’epoca, o alla formazione pedagogica di
allievi in grado di recepire e proseguire l’insegnamento del maestro. Ma non si
parla mai direttamente di bene sociale, se non passando attraverso l’istanza del
singolo. È evidente allora che il perfezionamento individuale per Lévi può
essere raggiunto soltanto tramite la conoscenza dei segreti della luce astrale.
Da qui il continuo insistere dell’autore su questo punto. Nel Corso di Filosofia
Occulta , raccolta del carteggio con il
barone Spedalieri, Lévi
tratta più marginalmente l’argomento e si concentra sui simboli: ma non si deve
ignorare che queste lettere sono mirate alla formazione pedagogica di un
allievo.
Nel carteggio si trovano degli spunti interessanti, come
quando Lévi ci ricorda che la prima lettera dell’alfabeto ebraico Aleph
simbolo dell’Unità mistica nelle sue quattro applicazioni - universale,
relativa, vivente, visibile - è raffigurata da una croce leggermente inclinata
che simboleggia il gesto del piegarsi, dall’alto in basso, nell’offerta
del dono della conoscenza divina all’uomo. Tuttavia, l’unità sintetica è
simboleggiata dal numero dieci, dallo Jod. Éliphas Lévi approda quindi ad una
metafisica monistica, perché è dall’unica sostanza, dall’Identico Dio, che
scaturisce il Tutto. Le serie numeriche sono riconducibili all’Unità Jod che le
genera e le comprende; solo successivamente si forma per emanazione la dualità e
la scissione dicotomica del fenomenico, perfettamente simboleggiata dal doppio
Aleph bianco/scuro, così come dal simbolo cinese dello Yin e dello Yang.
Lévi ritorna anche a perpetuare gli stessi errori già
palesati nei precedenti scritti. Come quando ripete che la Luce universale,
manifestazione esteriore del Verbo, si specifica differenziandosi secondo gli
enti attraversati. Così la stessa Luce universale diventa luce astrale
negli astri e luce magnetica “negli esseri che producono gli astri”, salvo poi
continuare ad usare allegramente il termine di “luce astrale” per
definire tutti questi casi. In altre parole prima definisce un genere universale
e le sue applicazioni specifiche, poi confusamente inizia a chiamare il primo
con il nome di una delle seconde. Questi slittamenti semantici delle definizioni
introdotte possono sconcertare più di un lettore ed in effetti l’aspetto
paradossale di questa omonimia gergale è che l’autore stesso indica i
significati che vuole dare ai termini, salvo poi disconoscerli, confonderli o
addirittura invertirli, già poche righe più sotto. In questo modo, il lettore si
trova a dover fronteggiare un’enorme confusione di vocaboli che vogliono dire il
contrario di tutto, ed è costretto ad uno sforzo interpretativo addizionale. Non
si può proprio sostenere che Éliphas Lévi sia stato un buon prosatore. Il
lettore deve dunque abituarsi a pensare che quando Lévi parla della “luce
astrale” in realtà intende riferirsi alla “luce universale”.
Continuando nelle sue lezioni Lévi arriva a tratteggiare un
altro punto essenziale, che dimostra ancora una volta l’importanza che ha nel
suo pensiero la conoscenza magnetica. Egli discorrendo delle tre modalità
d’espressione estrinsecate dalla sostanza monista - ossia dei tre principi
alchemici dello zolfo, del mercurio e del sale - riconosce che la Grande
Opera non è certamente la produzione materiale dell’oro, ma il controllo del
processo della materia universale. Quest’ultima è unica e sempre in
movimento nelle direzioni più diverse. Mediante il potere magnetico l’iniziato
può controllare il movimento e dirigerlo a suo piacimento, a patto di essere
riuscito ad ottenere quell’equilibrio interiore e quella conoscenza di cui Lévi
ha più volte parlato: “La luce astrale, divenuta luce vitale o magnetismo nei
viventi, è una calamita di grande potenza, essa attira e respinge gli oggetti
che gli indica l’istinto, piuttosto che la volontà. Le medium sono delle
calamite sregolate”. Lévi respinge la possibilità di una gnosi diretta
dell’Essere supremo, perché Dio sfugge alle leggi dello spazio e del tempo. In
realtà noi possiamo arrivare a conoscere soltanto un riflesso di Dio, perché
Egli si specchia nella Sua Sapienza ed è quest’immagine doppiata il dono della
gnosi. La seconda Sephirot Hokmah “Sapienza”, quindi, non è altro che la
trasposizione allegorica dell’aristotelica concezione del pensiero divino che
contempla sé stesso, mentre la conoscenza umana passa piuttosto per la terza
Sephiroth Binah “Intelligenza”. Secondo l’Albero della Vita cabbalistico, l’uomo
è destinato a cogliere soltanto il riflesso del pensiero divino, ma se
erroneamente scambia il Doppio con l’Autentico è condannato a vivere nell’ombra
e nell’ignoranza. Il sapiente è in grado quindi di distinguere la Luce
dall’Ombra, l’Ente dal Riflesso, ma il superamento sintetico delle
dicotomie del mondo fenomenico spetta solamente all’autentico Messia: “Così
l’armonia nel binario o la realizzazione creatrice dell’equilibrio universale,
la manifestazione di ogni idea in ogni forma, e la identificazione dei sessi in
un matrimonio veramente uno e indissolubile, tale deve essere, in effetto, il
Messianismo o il regno del Cristo come Messia”. Il Messia, dunque, per Lévi,
è colui che restaura l’Unità originale scissa dalle antitesi del mondo sensibile:
“allora i due sono uno; allora ciò che è interiore diventa esteriore; allora
non vi è più né uomo né donna; vi è l’essere umano, completo ed unico in due
metà inseparabili”. Éliphas Lévi in questo passo si richiama alla versione
platonica del mito dell’Androgino, scisso da Zeus in due metà anelanti al
ricongiungimento unitario Ma è nella lettera del 26 marzo 1862 che si registra
una sorprendente affermazione. Spiegando al suo allievo il valore del ternario,
Lévi asserisce che nella Cabbala “cristiana primitiva” la trinità originaria è
stata manipolata, perché è stata sostituita la persona del Figlio a quella della
Madre. Si sarebbe introdotta perciò la triade Padre/Figlio/Spirito in
luogo della primordiale Padre/Madre/Spirito, e questo semplicemente per
rimuovere la costellazione di idee che da sempre richiama l’idea del Femminile.
In altre parole le idee di passività e cedevolezza, tipiche dell’archetipo
materno, sarebbero state ritenute dai primi cristiani non adatte a rappresentare
il divino, in quanto l’Uno deve cancellare da sé ogni traccia di scissione. Ad
onor del vero, è già un errore parlare di una Cabbala “cristiana
primitiva”, perché la Cabbala cristiana è un adattamento dell’originale Qabbalah
giudaica, operata da alcuni umanisti del quattrocento, il più famoso dei quali è
Pico della Mirandola. Si tratta quindi di una sorta di ermeneutica cristiana
agli originali testi della mistica giudaica. Inoltre, se l’archetipo della
Grande Madre, secondo alcuni autori come Eliade, richiama la priorità dei riti
agrari e quindi l’invenzione dell’agricoltura, al suddetto passo di Lévi si
potrebbe concedere il beneficio del dubbio, se non fosse che la pessima
abitudine dell’autore di non riportare le fonti, annulla qualsiasi tipo di
indulgenza verso le sue asserzioni. Se in ogni suo scritto Éliphas Lévi si
limita ad asserire non citando mai le fonti, meno che mai si può sperare che
possa incominciare a farlo ora in un carteggio con un allievo, in cui
preferisce, al contrario, conferire un velo di mistero alle proprie
affermazioni. In ogni caso le tesi di Eliphas Lévi, in assenza di riferimenti
bibliografici, rimangono non dimostrate storicamente; anche se proprio ai
giorni nostri altri autori hanno iniziato ad indagare sulla strana rimozione,
operata dalla Chiesa Romana, dell’originario principio Femminile dal
Cristianesimo delle origini. Comunque sia, a detta di Lévi, la scelta per
l’ipostasi del Figlio garantiva maggiormente il richiamo all’idea dell’attività,
più consona al Principio divino.
Nella lettera del 2 aprile, Éliphas Lévi conferma che quello
che intende con “Luce universale” - o “astrale”, secondo la nota reiterazione
della traslitterazione semantica - è qualcosa di più della stessa luce come
viene comunemente intesa dalla scienza, ma anche dal senso comune: “La luce
universale rivela le sue quattro proprietà analoghe alle lettere del santo
tetragramma, in quanto serie distinte di fenomeni che si chiamano
elettricità, magnetismo, calore, e la luce o splendore. Poiché quello che
i nostri fisici moderni chiamano luce non è che uno dei fenomeni della
luce, l’irradiazione visibile”. Si tratta dunque di una sorta di
sostanza primordiale, onnicomprensiva, ma capace di accumularsi in direzioni
determinate mediante l’influsso di correnti magnetiche prodotte
inconsapevolmente o meno dagli esseri viventi. Negare la possibilità che in
alcuni punti dello spazio possano verificarsi delle concentrazioni magnetiche di
luce astrale, ammettendo al tempo stesso anche l’onnicomprensività della materia
universale, porterebbe a postulare una sorta di ricaduta parmenidea nell’Essere
come sfera immobile ed eterna. Si dovrebbe rendere conto della possibilità del
divenire all’interno dell’assenza di spazio, saturato di mathésis universale,
perché il tempo è possibile solo in presenza di fratture epistemiche e
discontinuità spaziali. in altre parole, senza soluzioni di continuità tra
essere e non-essere, presenza ed assenza, il divenire non è possibile, perché la
temporalità è comunque l’occupazione di uno spazio vuoto o la regressione da uno
saturo di sostanza. Il problema metafisico, com’era da aspettarsi, non sfiora
nemmeno la mente di Éliphas Lévi, troppo intento a dare sfoggio di cultura
davanti all’allievo. L’unica “ancora di salvataggio” che possiamo lanciare
all’autore è quindi quella di ipotizzare la presenza di discontinuità
ontologiche all’interno dei topoi attraversati dai flussi magnetici: ma non nel
senso di una plausibilità per punti assoluti di saturazione ed assenza di luce,
bensì relativa. Vi sarebbero dunque dei centri di maggior concentrazione
magnetica, ma non delle zone completamente svuotate di luce astrale. Solo questa
possibilità salva la teoria di Éliphas Lévi dall’impasse del monismo ipostatico.
Nel proseguo della lettera, Lévi traccia una serie di riduzioni progressive per
induzione all’unità, dapprima riconducendo i cinque sensi al senso interno e a
quello esterno - il cui comune denominatore chiama “tatto”- successivamente
riducendo i quattro elementi al fisso, al fluido ed al volatile, poi allo
stabile ed al mobile, infine alla sostanza. Come d’abitudine l’occultista
francese si guarda bene dal dare spiegazioni all’attonito barone, che egli al
contrario reputa “il più avanzato in teosofia” trai suoi allievi. Ma è tutto il
“corso” di filosofia occulta di Éliphas Lévi a fare acqua, perché l’autore
si dimostra superficiale, approssimativo e fumoso fino all’esasperazione.
Cerchiamo un ulteriore esempio. Nella lettera del 1 maggio, Éliphas Lévi
sostiene che “Il nome di Dio è in quattro lettere in quasi tutti i popoli del
mondo: JHVH per gli ebrei; ZEUS per i Greci, ALLAH ( le cui lettere sono
eventualmente 5 e non 4, N.d.R.); AURA per i Persiani; THMD per i Magi; ADAD per
gli Assiri, TARRA o TARO per i Ginnosofisti. il segno di Dio è dunque
essenzialmente la croce; anche prima del cristianesimo”.
Ora, a parte il fatto che non si capisce perché solamente in
alcuni casi le vocali non debbano essere considerate come lettere, ma come si
può dichiarare che “Il nome di Dio è in quattro lettere in quasi tutti i popoli
del mondo”, analizzando un elenco comprendente soltanto sei civiltà antiche più
una scuola di sapienti? Si tratta di un’evidente generalizzazione affrettata.
Nella lettera del 30 maggio Éliphas Lévi ritorna ad
evidenziare la centralità della figura di “Maria” identificata come
incarnazione “femminile” del Verbo - quella “maschile rappresentata da Gesù -
in grado di ascendere in Cielo con il Redentore. Il Cristianesimo avrebbe
sempre disconosciuto e rimosso questa centralità, tuttavia Lévi finalmente si
prodiga ad indicare come fonte della credenza un passo del Cantico dei Cantici
“Quae est illa quae procedit sicut aurora consurgens, innixa super sponsum”,
tradotto dall’occultista francese con “Chi è questa bellezza che sale nel cielo
appoggiata al suo amato bene come l’aurora che annuncia il levar del sole?”.
La fonte di Lévi è quindi solamente un passo, tradotto
peraltro in maniera approssimativa, in cui l’autore identifica arbitrariamente
“illa” con la Vergine. Lévi non presenta dei documenti o dei testi per
avallare l’ipotetica allegoria, ma solo questo breve passo allegramente
decontestualizzato dalla struttura del poema ed in cui opera un’evidente
forzatura esegetica. Nessun dubbio che Éliphas Lévi stia parlando per metafore
per far colpo sul suo allievo e millantare così conoscenze superiori, ma la sua
caduta nel dogmatismo appare irrefrenabile, così come in generale una desolante
assenza di metodologia a supporto di bizzarre e acritiche asserzioni. Nella
parte finale del Corso di Filosofia Occulta, Lévi inizia la sua lezione sul
pentagramma e finisce trattando del Diavolo. Il pentagramma è definito anche la
“stella dell’Epifania”, i cui vertici sono i Re Magi, la Vergine Maria e Gesù.
Si tratta quindi di un simbolo del sapere divino, ma qualora la stessa stella
venga rovesciata acquista subito un altro significato, diventa espressione del
demoniaco. Il pentagramma rovesciato è il simbolo del Diavolo, perché in esso si
iscrive la figura del caprone, il tipico animale con cui Satana ama
manifestarsi, una delle sue forme predilette. Nel definire il Diavolo, Lévi
aderisce alla tipica visione giudeo-cristiana, con la notevole differenza che
egli contesta l’esistenza effettiva dell’entità diabolica “Satana”. Nega
cioè che il Diavolo sia uno spirito vivente o un’incarnazione metafisica, ma con
una presa di posizione “nominalista” lo riduce ad essere il simbolo della
regressione compulsiva. Il Principe delle Tenebre non è altro che “lo spirito
d’accecamento, di fatalità e di vertigine”, lo spreco dell’esistenza nella
dispersione dei desideri senza fine, la disintegrazione atomistica della
Coscienza nei vortici demoniaci delle correnti magnetiche sregolate,
“un’analisi senza sintesi”. abbandonandosi al Diavolo, l’uomo regredisce alla
stadio bestiale in cui le pulsioni si scatenano libere e selvagge contro i
bastioni dell’Io sublimante: in una parola, per Éliphas Lévi il Diavolo è
l’archetipo dell’irrazionalità assoluta, della sragione. Curiosamente Lévi nel
ripudiare l’esistenza sostanziale del Diavolo, pur ammettendo l’influenza
corruttrice del demoniaco all’interno delle regressioni compulsive più bestiali,
in qualche modo anticipa - malgrado le notevoli differenze teoriche - la futura
corrente tardo novecentesca del satanismo “razionalista”. Nel satanismo
contemporaneo, il filone “razionalista” identifica Satana con l’archetipo della
trasgressione “libertina” contrapposta alla morale convenzionale, all’interno di
un progetto di slancio prometeico teso ad oltrepassare i limiti dell’umano e ad
ottenere la realizzazione di una super-coscienza magica e sciamanica. Questa
corrente però si rifiuta di fornire una risposta positiva all’esistenza concreta
di Satana, ossia mantiene un atteggiamento essenzialmente “agnostico”, in
disaccordo con il filone del satanismo “occultista” che viceversa crede
nell’individualità effettiva del Diavolo. Éliphas Lévi, pur non potendo essere
qualificato in nessun modo come satanista, preannuncia la successiva riduzione
simbolica dell’Avversario in virtù dell’identificazione con il caos e la
dissoluzione, fornendo così spunto alla posteriore ala razionalista: “è
così che Dio non può essere nel diavolo, perché questi è il tipo della
irrazionalità più assoluta. Dunque il diavolo esiste come concezione negativa
dello spirito, ma come creatura di Dio non esiste certamente”. Va da
sé che non esiste alcuna tangenza sostanziale tra l’occultista francese e il
satanismo; ma del resto per chi scrive è inevitabile il rischio di diffondere
idee che si presteranno ad essere deformate e stravolte. In ogni caso per
Éliphas Lévi il Diavolo è l’espressione dell’irrazionalità umana - connaturata
qui come si è detto con il caos delle compulsioni bestiali - mentre per il
satanismo “razionalista” le stesse pulsioni s’inquadrano in un paradigma
antropocentrico di liberazione prometeica dell’uomo. Ovviamente le espressioni
“razionalismo” e “irrazionalismo” acquistano significati differenti all’interno
del discorso di Lévi e in quello dei satanisti. Per l’occultista francese,
l’irrazionale è il mondo oscuro delle pulsioni selvagge, contrapposto al dominio
della morale e della cultura. Il satanismo contemporaneo, invece, può attingere
a piene mani da tutto il filone dell’irrazionalismo novecentesco e qualificare
come “razionale” e “umanesimo” la dialettica della liberazione delle compulsioni.
Per Éliphas Lévi, uomo dell’ottocento, invece il Diavolo è ancora da condannare
perché è il simbolo della bestialità umana.
Il carteggio si chiude, peraltro, con un’apparente presa di
posizione anticattolica ed anticlericale, ancor più sorprendente se si ricordano
i motivi che avevano indotto l’autore a distaccarsi dalla Massoneria. Tutto d’un
tratto Lévi contesta l’insegnamento seminaristico, gli esercizi spirituali di
Sant’Ignazio, e deride causticamente il sacerdozio, descrivendo “il prete che
ride egli stesso di quello che insegna, e che trascina, la sua ipocrisia
malcelata come una sottana sbottonata”. In realtà, il vero bersaglio di Lévi
non è la verità cristiana, ma gli strumenti attraverso i quali viene divulgata
la dottrina. Egli contesta la teologia, il suo impianto aristotelico e
tomistico strutturato nella produzione tipica dell’età scolastica. Per Lévi, la
teologia in quanto disciplina mutuata dalla riflessione filosofica, non è in
grado di cogliere le verità rivelate che solo possono essere svelate dalla
purezza della fede. La teologia, forgiata dalla stessa ratio filosofica che ha
innervato lo sviluppo del possesso scientista della Natura, non è adatta a
penetrare i misteri della Rivelazione, ed è allora necessario ritornare a
dividere la fede dalla scienza. Per Lévi le verità della fede, non possono
essere colte dalla scienza, e viceversa. Ci si potrebbe domandare com’è
possibile sostenere questa posizione in raffronto al sincretismo accentrato
sulla commistione tra mondo dell’arcano e spiegazioni scientifiche, che l’autore
ha sempre dimostrato di prediligere. Semplicemente, Lévi considera l’arcano
dimostrabile con il metodo scientifico, alla stregua di semplici fenomeni
naturali ancora sconosciuti. Al contrario, egli reputa le verità rivelate dal
Cristianesimo appartenenti ad un altro ambito, alla sfera della fede
completamente eterogenea ai fenomeni magnetici e probabilmente alla stessa
magia, che per lui rimane essenzialmente una scienza. Con quest’interpretazione,
la difficoltà sembrerebbe svanire perché ancora una volta, fede (Cristianesimo)
e scienza (Magia) sono destinate a non incontrarsi. Si deve tuttavia ricordare a
corollario di quanto sostenuto da Lévi, che solo dal XIII secolo la teologia ha
preso questo tipico sviluppo aristotelico, mentre in precedenza esisteva una
teologia “simbolica” molto prossima a ciò che noi oggi qualifichiamo come
“esoterico”.
Nel Libro dello Splendore, uscito
postumo dopo la sua morte, Éliphas Lévi tratta principalmente del trattato la
Grande assemblea del Sefer ha-zohar. Come nel caso del Corpus Hermeticum, anche
lo Zohar era inizialmente ritenuto più antico di quanto non fosse in realtà. Il
testo è un commento del II d. C. alla Torah del dottore palestinese Šim’on
bar Yoha’y. Dopo lunghe controversie tese a smentire o a confermare la presunta
datazione, Gershom Scholem attribuì l’opera al mistico castigliano Mosêh de León
(1240-1305). Tuttavia, alcuni studiosi hanno identificato in Yosef Giqatilla
(1248-1325) il misterioso autore del commentario; mentre un’ulteriore corrente
ha visto nello Zohar l’opera non di una singola mano, ma piuttosto di un gruppo
di mistici. La Grande assemblea, insieme alla Piccola Assemblea, costituisce un
testo propedeutico fondamentale alla qabbalah, al cui interno sono riproposte le
visioni estatiche del cenacolo di Šim’on. Tuttavia nel testo di Lévi si presenta
subito una prima difficoltà: egli traduce “Grande Sinodo” - a cui è
dedicato la parte prima del volume - con Idra Zuta, mentre ci risulta che
l’espressione corretta sia piuttosto Idra rabba - viceversa “Piccola assemblea”
si dovrebbe tradurre proprio con Idra zuta -. In attesa di risolvere il dilemma,
passiamo ad analizzare alcune considerazioni dell’autore nella sua prefazione.
Éliphas Lévi ritiene che gli ebrei possedessero le chiavi di una antica
conoscenza, che solo in parte si sarebbe trasmessa nella costruzione paolina del
nucleo cristiano originario, costituito dall’autentica predicazione di Gesù.
Parte di questo sapere primigenio sarebbe, invece, conservato nel Vangelo
di Giovanni. Sappiamo oggi che alla luce delle recenti scoperte a Qumran nel
1947, potrebbero essere ricondotti alla dottrina degli esseni non solo gli
elementi concettuali e lessicali delle scritture di Giovanni, ma anche l’essenza
dell’insegnamento autentico di Gesù. È una questione però a cui devono
rispondere gli esperti che si occupano a tempo pieno del problema: è
irragionevole che le risposte siano fornite da sedicenti esoteristi esponenti di
conventicole contemporanee, quindi tantomeno si potrà pretenderle da noi, che
restiamo dei semplici storici delle correnti esoteriche occidentali. Nella
Prefazione, l’autore inoltre auspica una sorta di nuova alleanza tra Giudaismo e
Massoneria:
“La pubblicazione di quest’opera farà comprendere l’odio
implacabile dei preti cattolici verso la Frammassoneria che è il giudaismo
riformato secondo il pensiero di Gesù e del suo apostolo prediletto Giovanni
Boanerges, la cui rivelazione cabalistica è stata sempre il vangelo del
cristianesimo occulto e delle parole di gnosticismo non profanato. A tali scuole
si riattaccano i giovanniti, i templari non idolatri e gli altri iniziati della
massoneria occulta. Là sono le chiavi dell’avvenire, perché là sono conservati i
segreti della rivelazione unica e universale, di cui il giudaismo, la prima e
forse la sola tra tutte le religioni, ha predicato al mondo la dottrina”.
La Massoneria dunque non sarebbe altro che una sorta di “giudaismo riformato”,
ossia “la prima e forse la sola tra tutte le religioni” ad aver
“predicato al mondo la dottrina”. Nella Cabbala cristiana si trova il legame tra
l’iniziazione massonica, il Cristianesimo “occulto” e la saggezza giudaica. La
“cristianizzazione” della Qabbalah operata a partire dal 1492 dagli umanisti
rinascimentali - il più famoso dei quali è senza dubbio Pico della Mirandola -
s’impone come nuova forma di letteratura tesa a adattare al milieu cristiano i
testi canonici dei maestri rabbini. La Massoneria avendo fatto propri gli
insegnamenti dei cabbalisti cristiani e dell’ermetismo alessandrino, può
aspirare a qualificarsi come un tipo di “giudaismo riformato”, in quanto il suo
simbolismo è ispirato da quello delle due correnti. Gli stessi vertici religiosi
del Giudaismo devono riconoscere in questa nuova veste l’identità massonica:
“il giudaismo deve tendere alla Frammassoneria una mano fraterna, perché la
professione di fede dei massoni non atei è il simbolo di Maimonide, e i
cristiani devono trovare nei riti degli alti gradi tutta la rivelazione
allegorica di Gesù Cristo. Nella Frammassoneria l’alleanza e la fusione del
giudaismo cabbalistico e del cristianesimo neo-platonico di S. Giovanni è già un
fatto compiuto”. Il Giudaismo ed il Cristianesimo quindi si ricongiungono e si
fondono armonicamente nell’insegnamento massonico, innervato dagli assunti
dottrinali dei cabbalisti cristiani. Tuttavia all’autore non sfugge che questa
sinergia eclettica potrebbe realizzarsi negli alti gradi, piuttosto che nella
Massoneria “azzurra”. I sistemi massonici degli alti gradi - “regolari”,
“irregolari”, o di “frangia” - contengono elementi che possono essere facilmente
ricondotti all’ ”esoterico”, mentre la Massoneria “azzurra” risente di un
retroterra culturale fortemente influenzato dal pensiero dei Lumi. Nelle
Costitutions (1723) di James Anderson, si affrontano tanto gli “Obblighi di un
Massone”, quanto la storia mitica dell’Istituzione. Nonostante questo, la storia
mitica resterà sempre trascurata nelle Obbedienze massoniche, che preferiranno
sempre concentrarsi sugli aspetti deistici degli Obblighi. Viceversa i sistemi
degli alti gradi hanno sempre cercato di contrastare il filone
illuminista-razionalista, con tentativi di autolegittimazione tesi a ricercare
nel più lontano passato le proprie origini mitiche, agganciandosi a tradizioni
particolari. Soprattutto lo “Scozzesismo”, ossia il Rito Scozzese delle
Massonerie “regolari” ha sempre fatto risalire la propria origine al confluire
di cavalieri del Tempio nelle Logge dei Costruttori, in seguito alla
soppressione dell’ordine da parte di Filippo il Bello. La Massoneria di frangia
“egiziana” fondata da Cagliostro ha invece sempre guardato alla antica sapienza
faraonica per articolare la filiazione dei propri riti. Non è questa la sede per
approfondire le differenze tra ciò che si può definire “regolare” , “irregolare”
o di “frangia”. In ogni caso la presenza di ciò che può essere definito un
“esoterismo massonico” è rinvenibile negli alti gradi, mentre un certo
simbolismo iniziatico non basta a regalare la stessa qualifica anche alla
Massoneria “azzurra”.
Al di là delle considerazioni che è possibile fare
sull’esoterismo massonico - o meglio sulla Massoneria esoterica - notiamo che
Lévi nell’introduzione fa riferimento alla sezione sulla Genesi tradotta da
Guillaume Postel. Non sappiamo tuttavia se avesse avuto una conoscenza diretta
anche della versione di K. Von Rosenroth, Kabbala denudata, Seu Doctrina
Hebraeorum trascendentalis et metaphysica atque theologica. In effetti,
l’occultista francese ama sovente dare sfoggio di conoscenze, alternando
citazioni di opere ed autori all’interno del suo stile di scrittura enfatico,
caratteristico della letteratura ottocentesca. La pessima abitudine alla
citazione superficiale del nome dell’autore o dell’opera - senza alcuna
trascrizione dei passi citati o dei concetti trattati - ingenera più di un
sospetto che l’occultista francese si limiti a delle conoscenze indirette, di
seconda mano. In altre parole, che non abbia veramente letto i libri che
cita.
In ogni caso, anche la lettura léviana dello Zohar presenta
qualche forzatura. Prendiamo ad esempio, i passaggi concernenti la descrizione
antropomorfica di Dio, in particolare il passo sulla “visione” dei capelli
divini. Nel racconto dell’opera, Šim’on bar Yoha’y sta commentando la Torah
assieme ad altri dottori. Nella letteratura rabbinica, la Torah è assimilata
alla sapienza divina e precede la creazione del mondo: è un velo che la luce
della conoscenza celeste attraversa nell’atto della manifestazione esteriore,
restandone irrorata. Come ricorda Giulio Busi, nell’ebraismo un vincolo
indissolubile viene stretto tra la Torah ed il mistero della creazione.
Nella dissertazione di rabbi Šim’on riguardo alla morfologia della testa divina,
da quest’ultima scendono fluenti capelli che ricoprono ambedue i lati. La fronte
del cranio è assimilata alla Volontà divina, ma anche all’amore: “Ma lassù,
quando si scopre la fronte, si trovano l’amore e la volontà perfetta, ogni
sdegno viene messo a tacere e viene dominato al suo cospetto”. Ora Éliphas Lévi
pur riconoscendo l’equiparazione simbolica della fronte di Dio all’amore
universale, inserisce nella traduzione un curioso passaggio che non esiste
nell’originale: “Tra le due parti della capigliatura suprema è il sentiero
dell’alta iniziazione, il sentiero del mezzo, il sentiero dell’armonia dei
contrari. Là tutto si comprende e si concilia. Là il bene solo trionfa e il male
non esiste”. Tuttavia, non crediamo che Lévi sia arrivato ad inserire
arbitrariamente un passo spurio nella versione zoharica con il preciso intento
di avallare il suo discorso sull’iniziazione e l’occultismo, quanto piuttosto
che sia caduto nell’eccesso di un’interpretazione forzatamente libera del
significato intrinseco dell’allegoria divina. Si tratterebbe quindi di una
mancanza di prudenza ermeneutica, piuttosto che di un’infrazione filologica vera
e propria. L’occultista francese carica quindi il testo di ulteriori significati
iniziatici ed esoterici, anche senza una reale necessità. Lo Zohar può essere
considerato come una teosofia giudaica, contrassegnata dalle tre idee
fondamentali che caratterizzano la corrente, ossia il triangolo Dio/Uomo/Natura,
il primato del mito, l’accesso diretto ai mondi superiori. Lo stesso Giulio Busi
ricorda che il senso dell’espressione “mistica” nell’ebraismo assume una
connotazione radicalmente diversa, da quella insita nell’omonima parola
occidentale. Il mistico cerca l’immediato trascendimento delle immagini in
vista della fusione con il principio divino, mentre lo gnostico
interiorizza, e rielabora all’interno di una dottrina, i segni della scala di
Giacobbe. Il mistico abbandona subito le immagini che ne delimitano il percorso
ascensionale, mentre lo gnostico le enfatizza. Il seguace della qabbalah,
attraverso i procedimenti della gimatreya, della ãtbas, del notariqon, s’immerge
nell’infinita combinazione dei significati che scaturiscono dalle lettere della
Torah. Le lettere acquistando il valore di teofanie, manifestazioni della
potenza divina, non possono essere trascese dall’oltrepassamento mistico
dell’immagine. La lettera torahica proprio perché ricettacolo ed immagine divina
non sarà mai superata dal cabbalista, che estrapola la conoscenza dal potere
intrinseco alla realtà grafica delle lettere. Ecco perché la qabbalah è una
mistica sui generis ed è più corretto inquadrarla come una dottrina e corrente
esoterica. Tuttavia lo Zohar, uno dei testi fondamentali da cui prende
ispirazione la qabbalah, è percorso principalmente da immagini, da visioni. Come
la descrizione, ricordata sopra, della fronte divina, simbolo dell’amore
universale e della volontà compiuta, o la percezione degli occhi di Dio. I due
occhi divini sono in realtà soltanto uno, perché solamente l’occhio superiore è
sempre vigile e non dorme mai. Quest’occhio simboleggia l’onniscienza e la
provvidenza divina. Al contrario, l’occhio inferiore, essendo privo di luce
propria, riceve quella del superiore: L’occhio inferiore simboleggia la
somiglianza umana al Creatore; se l’occhio superiore non scrutasse l’inferiore,
purificandolo dalle sue imperfezioni, il creato cesserebbe di esistere: “ Quello
sonnecchia spesso, perché è fatto a immagine dell’uomo, ed è a lui che si parla
quando si dice: Signore svegliati e porta i tuoi sguardi su di noi”. In termini
platonici, è attraverso l’occhio inferiore che l’uomo partecipa della sua natura
divina, poiché è lo sguardo che discende dall’Alto a ri-unire la
copia umana all’Archè. I due occhi privi di palpebre sono un in verità uno solo,
sempre aperto e gioioso, mentre la dualità fenomenica è solo apparente e
limitata al mondo del divenire, ricondotta all’unità dal principio trascendente.
L’assunto dell’occhio singolo esprime dunque una costruzione monista in cui il
molteplice scaturisce dall’Unico; solo il regno caduco e transeunte della physis
soggiace all’illusione dicotomica che inganna e raddoppia ciò che in realtà è
identico, cioè l’occhio singolo. Dio inoltre ha tre teste - che si fondono in
un’unica testa superiore , da cui fluenti e candidi capelli scendono “e vengono
a rischiarare la notte” - e due facce. La prima faccia contempla il
segreto dell’En sof, ed è chiamata Arik anpin, “Lungo di volto”; mentre la
seconda scruta l’esterno ed è conosciuta come Ze’er anpin, “Piccolo di volto”.
Il primo anticipa la creazione e la conoscenza, viceversa il secondo scruta il
creato. Lo Arik anpin è la fonte centrale della luce che irradia da destra tutto
il molteplice, mentre soltanto con lo Ze’er anpin si determina la dicotomia tra
la destra della benevolenza e la sinistra che è rigore: per questo il secondo
volto è anche denominato l’“Irascibile”. La visione antropomorfica dell’Idra
rabba prosegue con la descrizione di altre parti del corpo divino come i capelli
e la barba, simbolo quest’ultima di purezza e saggezza. In queste pagine
osserviamo come la tecnica delle corrispondenze - uno dei capisaldi del pensiero
esoterico - contribuisca a rendere rappresentabile all’occhio umano il mistero
del Trascedents. L’analogia tra micro e macrocosmo, aiuta il sapiente a
raffigurare l’Essere supremo ad immagine e somiglianza dell’uomo, con gli stessi
attributi corporei che rimandano analogicamente ad attributi divini
perfettissimi ed elevatissimi, posseduti dai mortali soltanto in una misura
imperfetta ed incompleta. Lo Zohar, ad esempio, descrive così i capelli di Dio:
“ Ogni ciocca è composta da trecentonovanta peli […] In tutte le ciocche sono
distribuiti trentuno mondi forti, che dominano e sottomettono: trentuno si
estendono da un lato e trentuno dall’altro. Ciascuno di questi mondi si divide
in mille mondi di desiderio di grande delizia: tutti sono nascosti nel principio
della barba, che include la forza” . Mentre i capelli e la barba dell’Arik anpin
sono assolutamente di luce, l’“Irascibile”- pur possedendo egli stesso questi
attributi divini - predilige svelarsi agli uomini alternando clemenza e
rigore, avvicendando così “un lato buono e uno cattivo, un lato di destra e uno
di sinistra, un lato di misericordia e uno di rigore”. Il perfetto equilibrio
dei due lati dello Ze’er anpin, è cabbalisticamente contrassegnato dal
bilanciamento nell’albero sefirotico di hesed, sefer dell’Amore, con gevurah,
sefer della potenza. Quando si realizza questa contrapposizione ipostatica, nel
mondo degli uomini regna la clemenza e la misericordia; ma quando il lato
sinistro di gevurah prende il sopravvento, l’ira divina si riversa sul Creato.
L’identificazione antropocosmica prosegue con la descrizione dei capelli e della
barba divina. I capelli sono morbidi e soffici, perché sono il medium del
cervello di Dio; attraverso di essi la Sapienza scorre dall’Arik anpin allo Ze’er
anpin, dal volto superiore a quello inferiore. La stessa lunghezza dei capelli
assicura l’onnipresente circolazione della sapienza, che, attraverso di essi, è
estesa a tutto il Creato. I capelli divini sono tutti bianchi come la neve,
colore della teofania della grazia, della rivelazione, oltre che della
conoscenza assoluta. Anche i peli della barba sono candidi come i capelli, ma al
contrario di questi sono duri. La robustezza della barba è chiarita dalla
necessità di fare discendere dal volto superiore l’inflessibilità dei tredici
principi di misericordia elencati dal profeta Mikéas (“Qual Dio è come te -
primo principio - che togli l’iniquità - secondo principio, e passi sopra alla
colpa - terzo, ecc.. Le trentuno ciocche dure corrispondono numericamente alla
parola El (“Dio”) e sottomettono trentuno mondi, a loro volta ripartiti in altri
mille di desiderio e delizia. La teofania allegorica della barba divina
racchiude tutto il processo necessario della discesa dal Principio al
molteplice.
Inizio del compendio di Éliphas Lévi in sintesi, questo
cenacolo di rabbini sta disquisendo su una proiezione antropocosmica. Dio - il
Principio creatore dell’Universo - è raffigurato con sembianze antropomorfiche,
ma nel pensiero messianico, come nella teologia cristiana, esiste da sempre il
problema di fornire una risposta alla presenza del male. La teodicea è qui
affrontata postulando la scissione dualista del principio unico, attraverso lo
stratagemma delle due teste o facce divine. Qualora ci soffermassimo
esclusivamente sul dualismo ontologico inerente all’essenza divina, cadremmo
vittime di una lettura superficiale e corriva, perché la contrapposizione del
viso d’ombra al viso di luce è solo apparente. Il viso che guarda i delitti
dell’uomo e si adira furiosamente è solo l’ombra, il velo del viso di luce
sempre raggiante e pacifico, autentico emblema- quest’ultimo- dell’essenza
divina che contempla, sorridendo, la giustizia eterna. Il volto d’ombra, da Lévi
denominato anche Microprosopo dal greco “piccolo volto, prósõpon”, è il
riflesso speculare alla natura umana, è il Dio che rassomiglia alla creatura
perfetta. Il volto d’ombra, in fondo, non è altro che la feurbachiana proiezione
antropocentrica nell’Immaginario religioso, o quello che Nietzsche definì come
il dionisiaco, il sentimento tragico della vita, la scissione inerente all’anima
umana cui si richiama lo stesso Lévi: “Le quattro lettere del nome di Jéhovah -
rappresentato con due visi come Giano. L’uno è giovane e bello come quello
d’Apollo, l’altro è contorto e grottesco come quello di Sileno. Apollo e Bacco
caratterizzano i due principi dell’esaltazione presso gli uomini: l’entusiasmo e
l’ubriachezza”. Ne La nascita della tragedia, Nietzsche non avrebbe potuto
esprimere meglio il concetto. Tuttavia a differenza del filosofo tedesco, per
Éliphas Lévi il dionisiaco più che l’amor fati esprime il velo, l’ombra della
Luce divina, “la sola che sia dato agli uomini di contemplare senza rimaner
ciechi per la luce.”. Non è possibile agli uomini comuni di percepire il lume
divino, ma soltanto le ombre come i prigionieri della caverna platonica: “il Dio
di luce è quello che i saggi sognano; quello d’ombra è quello che sognano gli
insensati. […] la faccia che le moltitudini adorano non è che il dietro della
finzione divina: è l’ombra posteriore di Dio visdebis posteriora mea”.
Che si tratti di un dualismo apparente, inerente alla
dimensione antropologica, è spiegato dallo stesso Lévi, che nega, ad esempio,
qualunque tipo di affinità tra la visione del Microscopio e la dottrina manichea:
“Questo Dio non è né l’Arimane dei Persi, né il principio cattivo dei manichei
[…] è un velo fatto all’immagine dell’umanità, di cui Dio stesso si degna di
svelare la sua gloria”. Siamo alla presenza, in definitiva, di una sorta di
kantiano uso regolativo che postula l’idea di Dio, in luogo di vantarne la
dimostrazione teoretica diretta: i deboli sguardi dell’uomo non possono cogliere
altro che le ombre (mito della caverna). Secondo Lévi, i due visi divini si
contrappongono come se ciascuno fosse il riflesso dell’altro, ma è evidente che
il Microprosopo è subordinato ontologicamente al volto di Luce, l’Arik anpin, di
cui è appunto l’ombra. Nella Grande assemblea, Šim’on e gli altri rabbini,
applicano il principio delle corrispondenze e dissertano sui dettagli
dell’immensa figura antropocosmica dai due volti. Tutto ha un senso ed un
significato analogico, dai ciuffi dei capelli a quelli della barba, dal naso ai
soffi che escono dalle narici. Ogni particolare è importante nella ricerca dei
segni e delle corrispondenze simboliche, ogni attributo antropocosmico ri-vela
l’epifania divina nel Creato. Così il naso dello Arik anpin soffia la vita
eterna, quello del Microprosopo il fumo ed il fuoco dell’ira infernale. Il
negativo dunque, inteso come principio del dolore e del male, non è altro che lo
Ze’er anpin, il “Dio nero” sovente scambiato per il diavolo, la deformazione
caricaturale del viso d’ombra: “a questa grande finzione dei rabbini che l’Arimane
dei Persiani, il Dio cattivo dei manichei e il diavolo dei cristiani debbono la
loro origine comune”. Lo Ze’er anpin, risvegliandosi, scuote la sua capigliatura
crespa facendo tremare il cielo, mentre i capelli dello Arik anpin sono luminosi
e morbidi. Ancora una volta, il viso d’ombra, il Dio nero, simboleggia il mondo
delle compulsioni selvagge proiettate nell’Immaginario mitico, il sonno della
ragione ed il disordine delle emozioni più che un vero e proprio principe degli
inferi. La sua collera terribile, ma passeggera, lo rende diverso ad esempio dal
Satana di Milton che con gelido raziocinio progetta la dannazione del genere
umano. Secondo Lévi non esiste in Dio la volontà di predestinare alla perdizione
eterna; la collera del Dio nero è più “volgare” che malefica, ma proprio per
questo destinata a scomparire come una perturbazione di fronte all’irrompere
dell’arcobaleno: “Il male che offende e irrita il Dio d’ombra non esiste per il
Dio di luce. Di fronte all’ordine assoluto, il disordine non esiste”. Del resto,
la subordinazione del viso d’ombra a quello di Luce è deducibile anche
cabbalisticamente. La barba dello Ze’er anpin contiene nove ciocche e non
tredici come quella del Arik anpin, perché il volto d’ombra non può produrre il
quaternario, appannaggio esclusivo del volto di Luce. Lo Ze’er anpin può
solamente moltiplicare per se stesso il ternario (3 X 3 = 9), tuttavia il nove
contiene in essenza la propria negazione:
“vi sono nove corsi d’angeli e del pari vi sono nove classi
di demoni. Il numero nove ha dunque la sua parte luminosa e la sua parte
d’ombra; ma il quaternario tetragrammatico è il numero perfetto che non ammette
negazione. La negazione del quaternario sarebbe la finzione mostruosa del male
assoluto. Sarebbe il Satan dei diavolisti”. Le nove ciocche della barba d’ombra
simboleggiano dunque la negazione, l’antitesi, delle corrispettive ciocche
dello Arik anpin (potenza/dispotismo, 1° luce; saggezza/ fanatismo, 2° luce;
intelligenza/dogma sottoposto al cambiamento fatale , 3° luce; bellezza/fede
cieca, 4° luce; giustizia/vendetta, 5° luce; misericordia/sacrificio volontario,
6° luce; vittoria/abnegazione volontaria, 7° luce; eternità del bene/inferno
eterno, 8° luce; fecondità/sterilità, 9° luce). Secondo Lévi il numero dieci non
possederebbe il negativo, in quanto numero della creazione. Tuttavia, ancora una
volta, l’autore ricorda come il Dio nero, non esista veramente, se non come
proiezione delle compulsioni e dei più ciechi terrori dell’uomo, come ombra
della radiosità divina appannaggio esclusivo dell’unico vero Dio di Luce.
Naturalmente, il Dio nero è più facilmente intelligibile al profano, proprio
perché più simile alla sua natura viscerale e carnale; raffigurarsi un Padrone
iracondo che si desta di tanto in tanto per tuonare contro i peccati dell’uomo è
speculare agli interessi dei preti. Se un elevato livello culturale e spirituale
consente di postulare l’esistenza del volto di Luce, non per questo permette di
oltrepassare lo stadio della mera formulazione dell’ipotesi di base. Il sapiente
sa- a differenza del volgo – che l’Arik anpin, il Dio che non s’irrita mai, è la
vera essenza divina: nonostante questo rimane vincolato al mondo della
rappresentazione, delle forme sfuocate ed inadeguate rispetto alla ridondante
presenza dell’essenza. In altre parole, neanche il sapiente- pur indossando meno
catene profane- riesce a fuggire del tutto dalla caverna della finitezza umana:
“ E se voi mi domandate quale differenza v’ha tra i due
vegliardi, io vi rispondo che i due rappresentano un solo e medesimo pensiero.
Questi sono i due lati di un’immagine sola: rivolta verso il cielo, l’immagine è
serena e splendida; rivolta verso le ignoranze (sic) e i vizi dell’uomo,
l’immagine è minacciante e tenebrosa”. Nella seconda parte, intitolata “La
gloria cristiana”, Éliphas Lévi delinea più chiaramente la sua posizione
“razionalista” in merito all’esistenza del demonio. Il diavolo non è un’entità,
ma una forza impersonale radicata nella menzogna e nell’oscurità deprivata della
pienezza dell’essere. Siamo alla presenza quindi di una sorta di “demonologia
negativa”: il diavolo come assenza e privazione del principio divino, Satana
come ombra del simbolo solare, allegorica raffigurazione dell’idea del bene.
Éliphas Lévi postula l’esistenza di una possibile affinità tra il volto d’ombra
e l’archetipo diabolico, entrambi proiezioni delle compulsioni e dei terrori
umani nell’immaginario mitico:
“Le intelligenze limitate non compresero questo dio fittizio
a due facce così differenti e l’idea di un dualismo assurdo s’introdusse nello
spirito di alcuni settari. Di là sorsero i demoni del falso Zoroastro. La faccia
di luce fu Orzmudt e la faccia di ombra divenne la testa fatale del capo
Animane. Quel giorno fu creato il Diavolo”. Dunque il diavolo è solo il
prodotto di proiezioni collettive. Domandandosi come il Maligno possa attingere
la sua linfa malefica, Éliphas Lévi tenta di elaborare una soluzione
di tipo socratico, finendo al contrario per cadere in un’inevitabile aporia. Dio
dà all’uomo la possibilità “di scegliere tra le tendenze superiori dell’anima e
i desideri che nascono dagli spiriti bassi di una natura limitata ed incatenata
a bisogni terrestri. Nessuno può amare il male per il male: noi troviamo alla
radice di tutti i vizi l’ignoranza e l’errore”. Ma la possibilità di
scelta deve implicare anche la possibilità di amare e scegliere il male in sé
stesso, così come la decisione deve concernere sempre tutti e due i corni del
dilemma. Sostenere, come fa Lévi, che alla radice del vizio c’è l’ignoranza,
significa ammettere, sull’estensione del modello socratico, che l’alternativa è
inesistente e la scelta obbligata.
Alla fine del Libro dello splendore, Éliphas Lévi illustra
due miti appartenenti a differenti contesti storico-culturali. Così dapprima si
sofferma su Krishna (La leggenda di Chrisna) e poi sull’assassinio di Hiram (La
stella fiammeggiante), il leggendario architetto del Tempio di Salomone,
la cui morte è stata simbolicamente ritualizzata dalla Massoneria azzurra e dal
Rito Scozzese Rettificato. In fondo un’ulteriore conferma dell’attitudine
sincretista di Lévi, come del resto di numerosi altri autori del XIX e del XX
secolo, sempre pronti a mescolare elementi eterogenei nello sforzo costante di
rintracciare il filo rosso della favolosa Tradizione primordiale.


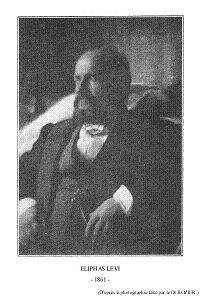

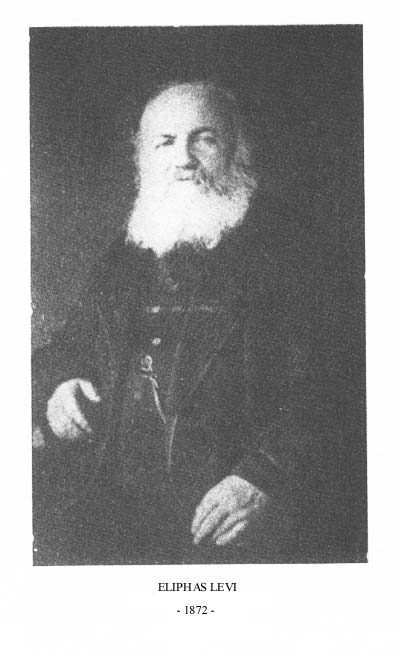


Si ricorderà che il barone ed Éliphas Lévi avevano intrecciato una fitta
corrispondenza durata fino al febbraio 1874. Purtroppo l’edizione italiana in
commercio non è rifinita sotto il profilo filologico, in quanto riporta
solamente le lettere di Lévi, ignorando invece quelli di Spedalieri, così che
abbiamo una prospettiva estremamente parziale del carteggio. Nonostante queste
difficoltà, fin dalle prime lettere si evince che Éliphas Lévi sembra
preoccupato per lo più di formare gradualmente il suo allievo, allorché gli
raccomanda incessantemente la pazienza e la perseveranza e lo prega di non
cercare di bruciare le tappe. Sporadicamente, in qualche passo del carteggio
pedagogico incentrato sui simboli, viene richiamata l’attenzione sulla priorità
della luce astrale e sui fenomeni da essa scaturiti: “In quanto ai vortici che
fanno muovere i tavolini, dovete comprendere che essi obbediscono alle cieche
fatalità della luce astrale”. Si accenna anche al “dono delle lingue” di cui
aveva parlato Guénon, ma in una prospettiva essenzialmente diversa. Mentre per
quest’ultimo si tratta della capacità di comprendere ecletticamente le diverse
forme storico-contingenti della Tradizione, dopo averne riconosciuta l’unità
metafisica essenziale, per l’occultista francese il “dono delle lingue” è
l’espressione piuttosto di una soprannaturale e misteriosa “erudizione”
linguistica. Il dono è uno dei risultati cui conduce il controllo della luce
astrale, in cui si riflettono come in uno specchio comune le “immagini e
reminiscenze” proiettate nei rimandi della totalità spazio-temporale. La
padronanza linguistica improvvisa di idiomi sconosciuti è resa possibile dalla
fruizione riflessa dei simulacri impressi come tracce dell’Immaginale,
dall’assimilazione del patrimonio filogenetico inciso nella struttura virtuale
del serbatoio onirico. I pensieri, le emozioni ed i sogni di tutti gli esseri
sono destinati ad ancorarsi come scorie, come residui luminosi di vissuti, in
grado però di assicurare il passaggio dalla potenza all’atto, all’operatore che
possiede i segreti delle leggi magnetiche. Le altre fonti della sapienza arcana
sono la Cabbala ed i Tarocchi, le sole in grado di svelare l’ontologia
“matematica” sottesa al fenomenico. Dietro alla fugacità del mondo del divenire,
si cela un ordine perfetto ed intelligibile strutturato sulla regolarità delle
leggi matematiche. Ma non si tratta tanto di un fondamento metafisico del
transeunte, perché qualsiasi causa che genera un effetto è al tempo stesso
contrapposta al prodotto. il matematismo ontologico inerisce, viceversa, anche
al mondo del divenire, dell’inganno fenomenico: “le lettere sono idee assolute.
Le idee assolute sono numeri. I numeri sono segni perfetti. Unendo le idee ai
numeri, si può operare sulle idee come sui numeri ed arrivare alla matematica
della verità”. Il lettore colto coglierà in questo passo dei rimandi alle
suggestioni lulliane sull’Ars Combinatoria, al tentativo metafisico di
determinare induttivamente i segni elementari all’origine della complessità. La
celebre “dottrina dei due mondi” - il mondo sensibile soggetto al divenire e
quello ultramondano dell’ipostasi metafisica - è stata divulgata in Occidente da
Platone, anche se la sua elaborazione risale ulteriormente a ritroso nel tempo a
Pitagora, l’orfismo, e ai viaggi di qualche sapiente in Egitto.
Opere Minori di Eliphas Levi
Home - Messaggi - Maestri - Autori - Arcana Arcanorum - Corpus Magiae - Biblioteca - Dossier - Napoli - Religioni - Luoghi - Vitriol - Miscellanea - Filmati